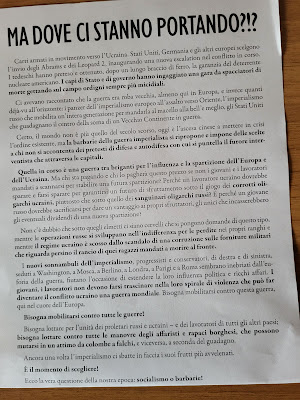martedì 4 aprile 2023
Sentenza Cassazione. Azione partigiani in via Rasella a Roma, legittimo atto di guerra.
Cassazione penale, sez.1 18 marzo 1999( c.c 23febbraio 1999) Pres. Teresi- Rel . MabelliniP.M. (Parz. Conf.)- Bentivegna e altri, ricorrenti.
Diritto penale militare
VIA RASELLA: LEGITTIMA AZIONE DI GUERRA Cassazione penale, Sez. I, 18 marzo 1999 (c.c. 23 febbraio 1999) - Pres. Teresi - Rel. Mabellini - P.m. (parz. conf.) - Bentivegna e altri, ricorrenti Il fatto commesso da un gruppo di partigiani in via Rasella a Roma il 23 marzo 1944 ai danni del battaglione di polizia tedesca occupante la città, per la qualità di chi lo commise, per l’obiettivo contro cui era diretto, e per la finalità che lo animava rientra, in tutta evidenza, nell’ambito di applicazione del d.lgs. lgt. 12 aprile 1945, n. 149, che considera azione di guerra ogni operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro tedeschi e fascisti nel periodo dell’occupazione nemica. Omissis. - I - Con “ordinanza” 16 aprile 1998 il G.i.p. del Tribunale di Roma disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di Bentivegna Rosario, Capponi Carla e Balsamo Pasquale, avente ad oggetto l’ipotesi del reato di strage prevista dall’art. 422 c.p. in relazione all’attentato compiuto in Roma, via Rasella, il 23 marzo 1944. Il procedimento era stato instaurato su denuncia di prossimi congiunti di civili rimasti uccisi nell’attentato (Iacquinti e Zuccheretti), o uccisi dai Tedeschi alle “Fosse Ardeatine” (Gigliozzi), nonché da Forti Giorgio quale “Segretario Generale Nazionale del Comitato di difesa del cittadino”. Chiesta dal P.m. l’archiviazione, per estinzione del reato in virtù dell’amnistia disposta con d.P.R. 5 aprile 1944, n. 96, trattandosi di atti commessi “per motivi di guerra” (nel senso di compiuti al fine di liberare l’Italia dall’occupazione tedesca, ma non qualificabili come “atti di guerra” in senso stretto) ed oppostesi le parti offese, il G.i.p. aveva ordinato ulteriori indagini, escludendo la notorietà dell’episodio, quanto alle concrete modalità con le quali esso si era svolto, e ritenendo necessario accertare se la strage corrispondesse al fine ritenuto dalle ricostruzioni storiche ovvero a meno nobili ragioni relative ai contrasti tra i gruppi politici che componevano il fronte di liberazione nazionale. In esito alle indagini, il G.i.p., con il provvedimento qui impugnato, ricostruiva il fatto, ed escludeva che esso potesse rientrare tra le azioni di guerra non punibili, indicate dal d.lgs. lgt. n. 194 del 1945 come “gli atti di sabotaggio, le requisizioni ed ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi ed i fascisti nel periodo dell’occupazione nemica”. Osservava che la qualificazione del fatto come “atto legittimo di guerra” attribuita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili (sentenza n. 3053 del 19 luglio 1957) non aveva valore nel procedimento penale, e che, trattandosi di reato che offende beni personalissimi dell’uomo, non era applicabile la “speciale causa di non punibilità” prevista dal d.lgs. lgt. 12 aprile 1945, n. 194. Ricordava che gli artt. 174 e 175 c.p.m.g. puniscono i metodi ed i mezzi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, sottolineando che, in caso di interpretazione diversa, mancherebbe di significato l’amnistia emanata, relativa a “qualsiasi tipo di reato”. Escludeva pertanto che il fatto potesse qualificarsi “atto legittimo di guerra”, e ravvisava invece tutti gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di strage. Riteneva, sulla base degli atti di indagine disposti, che l’attentato, nell’intenzione degli agenti, fosse stato progettato ed attuato sicuramente a fini patriottici indicati dal d.lgs. lgt. n. 96 del 1944, e disponeva di conseguenza l’archiviazione degli atti dichiarando estinto il reato per amnistia, in conformità a quanto richiesto sin dall’inizio dal P.m. Osservava poi che nella fase delle indagini preliminari non è consentita l’applicazione dell’art. 129 comma 2 c.p.p., con esame del merito, riservato al processo in senso proprio, e che quindi il giudice era esonerato “da ogni valutazione circa l’applicabilità o meno alla presente fattispecie delle disposizioni di cui al d.lgs. lgt. 12 aprile 1945, n. 194 sulla non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti nell’Italia occupata”; aggiungeva da ultimo: “Dopo tutto quanto sin qui esposto, ci si potrà forse chiedere alla fine se quel che avvenne in via Rasella il 23 marzo 1944 sia stato veramente necessario od anche soltanto opportuno, avuto riguardo alla prevedibilità di una spietata reazione da parte dei tedeschi. Ad avviso del decidente, però, tali questioni, sulle quali si sono insistentemente soffermate le parti offese, se possono trovare legittimo ingresso nell’ambito di un dibattito etico, politico e storico, non possono assumere rilevanza giuridica alcuna ai fini del presente procedimento. Né, d’altro canto, è consentito al giudice esprimere valutazioni che non siano estremamente pertinenti al ‘thema decidendum’ ad esso assegnato”. II - Hanno proposto ricorso in cassazione Balsamo Pasquale, Bentivegna Rosario e Capponi Carla, partecipi all’attentato, deducendo i seguenti motivi, approfonditi dalla memoria difensiva successivamente depositata. 1) Il provvedimento impugnato doveva considerarsi abnorme, poiché il giudice, prima di affermare di non poter scendere nel merito, come consentito nella fase dibattimentale dall’art. 129 comma 2 c.p.p., e di essere esonerato dal valutare l’applicabilità alla specie del d.lgs. lgt. 12 aprile 1995, n. 194 sulla non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti nell’Italia occupata, si era profuso sul tema, giungendo alla conclusione che l’attentato di via Rasella G GIURISPRUDENZA Decisioni commentate 737 DIRITTO PENALE E PROCESSO n. 6/1999 non poteva essere qualificato come atto legittimo di guerra, sulla base di una discutibilissima analisi delle disposizioni di diritto internazionale e della normativa post-bellica. La costruzione irrituale, fondata anche su precedenti giurisprudenziali distorti, qualificava l’ordinanza tra i cosiddetti “atti extra-vagantes” ricorribili per cassazione. 2) Le valutazioni espresse dal G.i.p. sulla non configurabilità dell’attentato di via Rasella quale atto di guerra, con riferimento al codice penale militare di guerra, non erano di sua competenza. La legittimità dell’atto era già stata comunque ritenuta in altre sentenze, tra cui quella emessa dalle Sezioni Unite civili della Cassazione, nella quale si era correttamente considerato che l’assoluta discrezionalità dell’attività bellica non consente al giudice alcun controllo diverso da quello relativo alle finalità dell’atto. 3) Il provvedimento di archiviazione non può mai contenere accertamenti pregiudizievoli alla persona sottoposta alle indagini o ai terzi, principio questo conforme all’art. 24 della Costituzione e disatteso nel caso in esame. 4) Dovrebbe altrimenti dichiararsi costituzionalmente illegittimo l’art. 129 comma 2 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non ne è consentita l’applicazione al giudice al quale il p.m. abbia richiesto l’archiviazione degli atti. Nella memoria difensiva l’eccezione di incostituzionalità veniva sviluppata in modo diverso, con riferimento all’art. 411 c.p.p., “in relazione agli artt. 3/1° comma, 24/2° comma, 111/2° comma Cost. per la parte in cui applica le disposizioni di cui all’art. 409 1° comma c.p.p., e quindi consente l’archiviazione degli atti anche nel caso in cui l’applicazione dell’amnistia sia subordinata ad un procedimento giurisdizionale di accertamento costitutivo nel quale la valutazione della sussistenza nel fatto di determinate circostanze (nella specie, la particolare finalità patriottica del fatto) e del loro valore rappresenta l’intervento necessario ed inderogabile della scienza e della volontà del giudice che contribuisce a rendere concreta ed effettiva la realtà estintiva astrattamente delineata dal legislatore”. Si rileva la disparità di trattamento tra i cittadini che a norma dell’art. 129 c.p.p. sono ammessi a dimostrare l’esistenza delle condizioni di cui al 2° comma dello stesso articolo, e perciò ad ottenere eventualmente una sentenza di assoluzione o di improcedibilità, e ad impugnare, se del caso, la sentenza stessa, in conformità al diritto inviolabile di difesa ed al principio di ricorribilità delle sentenze, e coloro che restano privati di tutti tali diritti e facoltà in forza di un sommario procedimento di archiviazione, che tuttavia motiva il suo aspetto decisorio con l’apodittica affermazione relativa all’esistenza del reato. L’incostituzionalità dell’art. 411 c.p.p. è eccepita nella memoria, con riferimento all’art. 77 della Costituzione, anche sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 2 n. 50 della legge delega n. 81 del 1987, che prevede la possibilità dell’archiviazione solo per manifesta infondatezza della notizia di reato, per essere ignoti gli autori dello stesso o per improcedibilità dell’azione penale, mentre le due fattispecie sono richiamate nella direttiva 52 fra i casi per i quali può essere pronunziata sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p., come modificato dalla l. 8 aprile 1993, n. 105. III - Il Procuratore Generale presso questa Corte nella propria requisitoria scritta disattende la tesi difensiva concernente l’abnormità del procedimento impugnato. Considera che “se non appare contestabile che il G.i.p., pur invocando principio del tutto diverso, si sia di fatto lasciato andare a giudizi di merito, peraltro “moralmente” sfavorevoli agli indagati, questa operazione - sui cui contenuti opinabili dal punto di vista giuridico e storico è opportuno in questa sede non soffermarsi per non introdurre ulteriori motivi fuorvianti - è stata attuata per così dire andando “oltre” quanto fosse per forma e sostanza necessario a dare concrete risposte alla richiesta di archiviazione. Questa sovrabbondanza per la sua “smaccata” ultroneità non è capace di comunicare i suoi “vizi” all’organica - e chiaramente sussistente - compatibilità con le premesse poste dal P.m. ossia al suo contenuto decisorio”. Ritiene manifestamente infondata la eccezione di costituzionalità proposta, considerando che proprio le censure dei ricorrenti sull’uso distorto del principio di cui all’art. 129 comma 2 fatto nell’ordinanza indicano come non sia verificabile in astratto la dedotta disparità di trattamento. Conclude per l’inammissibilità del ricorso proposto. IV - Ciò premesso, la Corte osserva quanto segue. 1) Il decreto di archiviazione disciplinato dagli artt. 408 - 411 c.p.p. è un provvedimento concepito dal legislatore come anteriore all’esercizio dell’azione penale, correlato alla insussistenza degli estremi per esercitarla, che in nessun modo può pregiudicare gli interessi della persona indicata come responsabile nella notizia di reato, o l’interesse della pubblica accusa a riaprire le indagini nel caso previsto dall’art. 414 c.p.p. Per tale sua natura, di provvedimento in qualche modo “neutro”, non ne sono previsti mezzi d’impugnazione. 2) L’unica forma d’impugnazione consentita contro il decreto di archiviazione è connessa alla sua eventuale abnormità, in virtù della giurisprudenza che ammette il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 111 della Costituzione, nei confronti del provvedimento caratterizzato da vizi “in procedendo” o “in iudicando” del tutto imprevedibili per il legislatore, il quale proprio per l’estraneità dell’atto al sistema legislativo non ha previsto contro di esso alcun mezzo d’impugnazione (sul punto, tra le altre, Cass., Sez. III, 8 agosto 1996, Cammarata, RV. 206058). Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (12 febbraio 1998, n. 17, Di Battista, RV. 209603) “è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e dalle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non ▲ estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo”. 3) I ricorrenti deducono l’abnormità del provvedimento di archiviazione adottato nei loro confronti per essere estinto “il reato contestato” (cfr. pag. 29 del provvedimento impugnato) per amnistia, siccome emesso in esito ad ampia e particolareggiata motivazione con la quale si è accertata la loro colpevolezza per il delitto di strage. La doglianza formulata, considerata in astratto, corrisponde al concetto di abnormità considerato, poiché la natura “neutra” del decreto di archiviazione, emesso in una fase in cui gli elementi relativi alla notizia di reato sono ancora amorfi e fluidi, è radicalmente incompatibile con la dichiarata e motivata attribuzione di un reato ad un determinato soggetto. Un provvedimento che abbia le caratteristiche denunziate nel ricorso si pone pertanto al di fuori del sistema legislativo, che impone l’esercizio in contraddittorio dell’azione penale prima dell’accertamento di un reato a carico di una persona denunciata. L’abnormità lamentata in coerenza alla natura del provvedimento impugnato rende quindi ammissibile l’unico mezzo d’impugnazione consentito nella ipotesi considerata. 4) Il ricorso, oltre che ammissibile, è fondato, poiché l’abnormità denunziata è reale. Il provvedimento di archiviazione impugnato, che l’art. 409 c.p.p. prevede sia emesso nelle forme del “decreto”, è qualificato come “ordinanza”, ed ha peraltro il taglio motivazionale tipico della sentenza, in quanto, dopo aver ricostruito il fatto ed il ruolo in esso svolto dai tre ricorrenti, per ben sei pagine (ff. 24-29) si esprime sulla qualificazione di esso e sulla configurabilità del delitto di strage. Lo schema è quello previsto dall’art. 129 c.p.p., del quale a pag. 35 il G.i.p. riconosce peraltro la inapplicabilità alla fase delle indagini, ammettendo espressamente che le questioni poste dalle parti offese, oggetto della motivazione precedentemente estesa, non potevano “assumere rilevanza alcuna ai fini del presente procedimento”. Osserva al riguardo il Collegio che ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p. l’archiviazione può essere disposta se la notizia di reato è infondata, ovvero perché manca una condizione di procedibilità, perché il reato è estinto o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. All’archiviazione non si applica l’art. 129 c.p.p., che al secondo comma dispone la prevalenza delle cause di declaratoria di non punibilità di natura sostanziale rispetto a quelle connesse alla estinzione del reato. La norma è infatti dettata per “ogni stato e grado del processo”, ed è quindi estranea alla fase in questione, anteriore all’esercizio dell’azione penale (in senso conforme, Cass., Sez. VI, 5 marzo 1998, Boccardi, RV. 210826; Sez. V, 18 marzo 1997, Giustini, RV. 207901; Sez. VI, 7 settembre 1994, Rosco, RV. 199084; sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta sul punto specifico con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., Cass., Sez. VI, 7 luglio 1992, Zanetti ed altri, RV. 191053, che ha escluso la disparità di trattamento denunziata rispetto al rinviato a giudizio nei cui confronti debba essere emessa sentenza di proscioglimento, in considerazione dell’assoluta diversità delle situazioni disciplinate, e dell’assenza, in caso di archiviazione, di diritti o interessi da tutelare in capo al soggetto). La inapplicabilità al decreto di archiviazione dell’art. 129 c.p.p. comporta che il giudice, al quale il provvedimento sia chiesto per motivi attinenti all’estinzione del reato, non debba motivare in ordine alla impossibilità di archiviare per motivi diversi, inerenti alla non configurabilità del reato. Si è ritenuto peraltro, in considerazione del favore che incontra nel nostro ordinamento la scelta della formula liberatoria più ampia, che il G.i.p. al quale sia stata chiesta l’archiviazione per difetto di una condizione di proseguibilità o di procedibilità dell’azione penale o per intervenuta estinzione del reato possa, in alternativa all’adesione alla richiesta del P.m., archiviare la “notitia criminis” per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 408 c.p.p. (in tal senso, Cass., Sez. VI, 19 ottobre-16 novembre 1990, Sica, RV. 185768, edita in Foro it., 1991, II, 516). Non è invece ammissibile che l’analisi e le conclusioni del G.i.p. in tale fase si rivolgano “in malam partem”, facendo precedere alla indicazione del motivo formale per il quale l’archiviazione è disposta una motivazione sostanziale, che concerna la configurabilità del reato e la responsabilità dell’indagato in ordine ad esso (nello stesso senso la sentenza sopra citata, che ha ritenuto l’abnormità del provvedimento con il quale il G.i.p., a fronte della richiesta del p.m. di archiviazione degli atti per estinzione dei reati per amnistia, prima di esprimersi in senso conforme aveva accertato con diffusa motivazione l’esistenza di elementi di responsabilità a carico del denunciato. Conformi Cass. Sez. VI, 7 settembre 1994, Rosco, RV. 199084, che ha ritenuto abnorme il decreto di archiviazione emesso per amnistia, preceduto dal rilievo che non risultava evidente l’insussistenza del fatto, e che la qualificazione giuridica era corretta; Sez. V, 9, 18 marzo 1997, Giustini, RV. 207901, in tema di provvedimento pronunciato prima dell’esercizio dell’azione penale, nel quale il g.i.p. con riferimento all’art. 129 c.p.p. ha usato la formula, anziché di archiviazione, di “non luogo a procedere a carico dell’indagato in conseguenza della morte di questi”, preceduta dalla valutazione sulla mancanza di manifesti elementi in base ai quali prosciogliere nel merito). Poiché nella specie il provvedimento impugnato ha assunto natura diversa da quella meramente dichiarativa e delibativa propria del decreto di archiviazione, e contiene uno specifico accertamento “in malam partem” espresso nei confronti di persone nei cui confronti l’azione penale non era stata esercitata, si ravvisa la sua abnormità in dipendenza dell’accertamento predetto, indipendentemente dalla correttezza o infondatezza delle motivazioni che tale accertamento sorreggono. Dalla ritenuta abnormità segue l’annullamento del provvedimento medesimo. 5) Le considerazioni che precedono evidenziano la irrilevanza, e al tempo stesso la manifesta infondatezza, della eccezione di costituzionalità proposta. Gli artt. 408 - 411 c.p.p. non danno spazio per valutazioni concernenti in positivo la responsabilità dell’indagato per un reato determinato, accompagnate dalla archiviazione della “notitia criminis” re- ▲ G GIURISPRUDENZA Decisioni commentate 738 DIRITTO PENALE E PROCESSO n. 6/1999 G GIURISPRUDENZA Decisioni commentate 739 DIRITTO PENALE E PROCESSO n. 6/1999 lativa, e non può profilarsi, né si profila nel caso di specie, la lesione dei diritti e degli interessi lamentata in conseguenza di un provvedimento che, in quanto abnorme, è ricorribile in sede di legittimità e che deve essere annullato. 6) L’annullamento del provvedimento, qualificato come abnorme, pone al Collegio il problema di ulteriormente provvedere in ordine alla possibilità di dare in questa sede le disposizioni necessarie per rendere la decisione impugnata conforme alla legge, a norma dell’art. 620 lett. l c.p.p. In questa prospettiva compete certamente a questa Corte l’obbligo di considerare se il fatto, quale emerge dalle richieste del P.m. e dalla ricostruzione attuata sulla base delle indagini disposte dal G.i.p., non risulti previsto dalla legge come reato: e ciò in relazione alle specifiche osservazioni formulate con il ricorso. Va osservato al riguardo: a) L’attentato di via Rasella del 23 marzo 1944 ai danni del battaglione di polizia tedesca “Bozen”, nel quale rimasero coinvolti alcuni civili italiani, fu compiuto mentre era in corso l’occupazione di gran parte del territorio nazionale ad opera dei Tedeschi a seguito degli eventi successivi all’armistizio dell’8 settembre 1943. A tale occupazione non si sottraeva Roma, che nonostante la sua qualifica di “città aperta” (attribuita unilateralmente dal Governo Italiano prima dell’armistizio: cfr. Cass., Sez. U. Civ., 19 luglio 1957 n. 3053, in Foro it. 1957, I, 1398), era presidiata da truppe tedesche e sottoposta ad un durissimo controllo di polizia militare e politica. Contro tale occupazione in Roma e in tutta l’Italia centro-settentrionale sin dal 9 settembre 1943 si erano andati spontaneamente organizzando gruppi di resistenza sia politica che militare. L’attentato, accuratamente preparato (cfr. anche pag. 33 provvedimento impugnato), fu deciso ed attuato da appartenenti a formazioni dei G.A.P. (Gruppi Azione Patriottica), dipendenti dal Comando Garibaldi per l’Italia Centrale, e comandati in Roma all’epoca del fatto da Carlo Salinari. Essi erano collegati alla Giunta Militare del C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) attraverso Giorgio Amendola ed altri. I G.A.P. rivendicarono apertamente la paternità dell’azione, diretta a contrastare l’occupazione tedesca ed a restituire le libertà conculcate dal regime fascista. L’azione fu attuata facendo esplodere, mediante detonatore collegato ad una miccia, 18 kg. di tritolo contenuti in un carretto per la spazzatura, in coincidenza del passaggio, usuale e previsto, di una compagnia del battaglione “Bozen”. Secondo la ricostruzione del consulente tecnico della parte offesa Zuccheretti, riportata nel provvedimento impugnato (pag. 14), l’esplosione dell’ordigno ebbe a determinare la morte di 42 soldati tedeschi (dei quali 32 morti quasi immediatamente e gli altri nei giorni seguenti), e di almeno due civili italiani, il minore Pietro Zuccheretti e Antonio Chiaretti. b) Il fatto oggetto della richiesta di archiviazione proposta dal P.m. e del provvedimento impugnato per la qualità di chi lo commise, per l’obbiettivo contro il quale era diretto e per la finalità che lo animava, rientra, in tutta evidenza, nell’ambito di applicazione del d.lgs. lgt. 12 aprile 1945, n. 194, che dispone: “Sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell’occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute dai comitati di liberazione nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita”. Dalle premesse che precedono consegue che devono essere considerati infondati i motivi per i quali il pubblico ministero che ha chiesto l’archiviazione prima, ed il G.i.p. poi, hanno escluso l’applicabilità della norma alla specie, sotto il profilo che le operazioni considerate dell’articolo unico del decreto luogotenenziale citato sarebbero esclusivamente quelle “di contorno”, non coinvolgenti diritti primari della persona umana. Il termine “operazioni”, applicato ad un contesto che storicamente è di lotta armata, comprende qualsiasi atto, anche cruento, volto a combattere il nemico. La “Legge di guerra” approvata con r.d. 8 luglio 1938, n. 1415, All. A, dedica l’intero “Titolo secondo” alle “operazioni belliche”, che comprendono “atti di ostilità” (Capo II, Sez. I) implicanti “l’uso della violenza” (art. 35), e il “bombardamento” (Capo I, Sez. II). L’interpretazione riduttiva del termine appare infatti non corretta dal punto di vista letterale, poiché contrasta con l’espressione “ogni altra” che immediatamente lo precede; collide con la struttura sistematica dell’articolo unico del decreto luogotenenziale, che collocando nell’ambito delle “azioni di guerra” gli atti menzionati non può prescindere da quelle che sono in genere le caratteristiche delle azioni nel cui novero gli atti medesimi sono inseriti; stride con la volontà del legislatore, desunta dalla situazione storica nella quale la norma è stata emanata, indirizzata ad attribuire riconoscimento di liceità ad ogni azione diretta alla liberazione del territorio nazionale ed alla fine del regime fascista, volontà palesemente espressa in una serie di disposizioni di legge dell’epoca e successive, che qui di seguito si richiamano. – Il d.lgs. lgt. 21 agosto 1945, n. 518, ha disciplinato “il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l’esame delle proposte di ricompensa” in dipendenza della lotta armata partigiana. – Il d.lgs. lgt. 5 aprile 1945, n. 158, ha riconosciuto la qualifica di “patriota combattente”, comportante benefici di vario genere, tra gli altri, “agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio” (art. 9 lett. a-, nel quale l’equiparazione tra combattimento e sabotaggio evidenzia come sia errato, dalla menzione del sabotaggio contenuta nel d.lgs. lgt. n. 194 del 1945 qui in esame, desumere un significato ridotto, concernente azioni di semplice “contorno”, del successivo termine “operazioni”). – Il d.lgs. C.p.S. 6 settembre 1946, n. 266, che ha disciplinato il risarcimento a carico dello Stato dei danni causati dalle “operazioni della guerra” poste in essere dalle forze armate nazionali, alleate o ne- ▲ miche, equipara alle forze armate “le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche”. – La l. 21 marzo 1958, n. 285, titolata “Riconoscimento giuridico del corpo Volontari della libertà (C.V.L.)”, ha riconosciuto il corpo stesso “ad ogni effetto, come corpo militare organizzato inquadrato nelle forze armate dello Stato”, con i conseguenti benefici economici e di carriera. Si tratta di provvedimenti normativi connessi alla nostra Storia, alla formazione della Repubblica Italiana ed ai principi sui quali la Costituzione si fonda (si pensi alla XII Disposizione Transitoria alla Costituzione), conformi alla “intenzione del legislatore” pur se considerata oltre al momento in cui è stata espressa ed in senso attuale. Né la circostanza che l’amnistia disposta con d.lgs. lgt. 5 aprile 1944, n. 96, avesse quale oggetto “tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la patria dall’occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse o conculcate dal regime fascista” (art. 1), è dato idoneo ad escludere che un’azione avente le caratteristiche e gli effetti propri dell’attentato di via Rasella rientri nell’ambito di applicabilità del decreto luogotenenziale n. 194 del 1945. La promulgazione dell’amnistia è precedente, non successiva, al d.lgs. lgt. n. 194 del 1945, che ha tolto in radice la natura di reato, inserendola tra le “azioni di guerra”, ad ogni “operazione compiuta da patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell’occupazione fascista”. Ed ha una sua innegabile e profonda “ratio” il fatto che, in quel momento storico, all’ampia formula dell’amnistia disposta per un numero grandissimo di reati, individuati soltanto in relazione alla finalità perseguita, si sia poi riconosciuta la totale irrilevanza ai fini penali di alcuni di essi, aventi caratteristiche soggettive, obbiettivi e modalità operative tali da renderli assimilabili ad ogni effetto ad “azioni di guerra”. Quanto alla “necessità di lotta” contro gli obbiettivi indicati, si rileva che la natura dell’attività bellica rende la valutazione sul punto discrezionale, evidentemente non sottoponibile da parte del giudice ordinario ad un controllo che coinvolga “a posteriori” la efficacia dell’operazione prescelta a conseguire gli obbiettivi strategici perseguiti. Nel caso di specie l’attentato, commesso nei confronti di una formazione nemica che occupava il territorio nazionale, volto a contrastrare l’occupazione stessa, appare caratterizzato da quegli inequivoci requisiti strutturali e teleologici che consentano al giudice di qualificare l’azione predetta come “azione di guerra” in base al decreto luogotenenziale citato. c) Si devono pertanto condividere le argomentazioni - richiamate espressamente dal G.i.p., ma dallo stesso disattese (cfr. pagg. 24 e segg. provvedimento) - con le quali le Sezioni Unite civili di questa Corte con la sentenza 19 luglio 1957, n. 3053, sopra citata, pronunciando in tema di risarcimento del danno richiesto dalle vittime civili dell’attentato di via Rasella, ha stabilito che “la lotta partigiana è stata considerata dalla legislazione italiana quale legittima attività di guerra”, con conseguente improponibilità dell’azione risacitoria proposta. La statuizione, è chiaro, non vincola il giudice penale, a norma degli artt. 2 e 3 c.p.p., nel senso che non opera con efficacia di giudicato, ma costituisce indubbiamente un precedente significativo per l’analisi penetrante ed esaustiva sviluppata sullo specifico tema concernente la qualificazione dell’attività svolta dai gruppi partigiani avuto riguardo, in particolare, alla diversa posizione attribuibile agli stessi in relazione, da un lato, agli atti di ostilità compiuti, all’epoca dei fatti in esame, nei confronti degli occupati tedeschi, e, dall’altro, al loro rapporto nell’ambito dell’ordinamento (interno) italiano. Diverse, ma da un attento esame non confliggenti, le situazioni e le conseguenti valutazioni recepite nelle pronunce degli organi della giustizia militare concernenti l’attentato di via Rasella, ed aventi per oggetto la “rappresaglia” attuata il giorno successivo dalle Forze Armate con l’uccisione di 335 cittadini italiani alle Fosse Ardeatine. Con sentenza 20 luglio 1948, n. 631, emessa contro Kappler ed altri (in “Rassegna della Giustizia Militare”, 1996, nn. 3-6, pag. 3), il Tribunale Militare di Roma, che pur ha escluso la legittimità della rappresaglia per violazione del principio della proporzione, ha negato la natura di legittima azione di guerra dell’attentato, in quanto non commesso da “legittimi belligeranti”, in rapporto alla clandestinità dell’organizzazione partigiana, all’epoca priva dei requisiti richiesti dall’art. 1 della Convenzione dell’Aia del 18 agosto 1907. Proposto ricorso da Kappler, il Tribunale Supremo Militare, con sentenza 25 ottobre 1952, n. 1711 (ibidem, pag. 83), ha rovesciato tale impostazione, dichiarando illegittimo l’esercizio della rappresaglia in relazione alla legittimità dell’azione italiana: “Via Rasella, alla luce delle norme del diritto internazionale, si pone in termini di rigorosa linearità: la sua qualificazione non può essere altro che quella di un atto di ostilità a danno delle forze militari occupanti, commesso da persone che hanno la qualità di legittimi belligeranti”. Il tema della liceità dell’attentato, collegato alla illiceità dell’atto ritorsivo attuato con l’eccidio delle Fosse Ardeatine, nelle due sentenze menzionate è stato affrontato in rapporto alla controversa qualità di legittimi belligeranti degli attentatori all’epoca del fatto contestato, e non poteva certamente essere risolto con riferimento al decreto luogotenenziale n. 194 del 1945, emanato successivamente alla “rappresaglia” in questione. Tale soluzione non era consentita né dall’art. 23 c.p.m.g. sulla ultrattività della legge penale militare di guerra, né dagli artt. 25 comma 2 della Costituzione e 2 comma 1 c.p., per i quali il riconoscimento della legittimità dell’azione di via Rasella, in quanto qualificata con effetto retroattivo “azione di guerra”, non poteva valere ai fini della individuazione dell’illecito penale contestato in quel procedimento. Restano quindi estranee al “thema decidendum” attuale le motivazioni, formulate nella prima sentenza citata, inerenti alla illegittimità dell’attentato con riferimento agli artt. 25 e 27 della legge di guerra (all. A al r.d. 8 luglio 1938, n. 1435, articoli di cui peraltro le Sezioni civili di questa Corte, nell’ambito di un “obiter dictum” contenuto nella ▲ G GIURISPRUDENZA Decisioni commentate 740 DIRITTO PENALE E PROCESSO n. 6/1999 G GIURISPRUDENZA Decisioni commentate 741 DIRITTO PENALE E PROCESSO n. 6/1999 sentenza citata, disconoscono l’applicabilità al caso di specie, in quanto tali norme erano dirette solo a limitare i poteri dello Stato italiano nei confronti dei cittadini di altri Stati con i quali sia in guerra), in rapporto alla clandestinità dell’organizzazione partigiana, all’epoca priva dei requisiti richiesti dall’art. 1 della Convenzione dell’Aia del 18 ottobre 1907, per la quale un atto di guerra legittimo può essere compiuto solo dagli eserciti regolari ovvero da corpi volontari che, oltre ad essere comandati da una persona responsabile per i subordinati, abbiano un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza, e portino apertamente le armi. Ma ciò posto in evidenza, non ne deriva affatto la non riconducibilità allo Stato italiano, per quanto si riferisce al coinvolgimento nell’attentato anche di vittime civili, dell’azione dei partigiani. Occorre rammentare infatti che, sin dopo la dichiarazione dello stato di guerra nei confronti della Germania (13 ottobre 1943), il Governo legittimo aveva incitato tutti gli Italiani a ribellarsi ed a contrastare con ogni mezzo l’occupazione tedesca (cfr. Cass., Sez. U. civ., n. 3053 del 1957 citata). Il fatto, innegabile, ma comune a tutti i movimenti di resistenza, del loro carattere clandestino nei momenti iniziali, non è affatto in contrasto, pertanto, con il riconoscimento delle attività in esame quali atti tipici di guerra. E la successiva legislazione si è limitata semplicemente a darne atto. d) La legittimità dell’operazione considerata, unitaria nell’azione e nello scopo perseguito, deve essere pertanto valutata nel suo complesso, senza che sia possibile scinderne le conseguenze a carico dei militari tedeschi che ne costituivano l’obbiettivo da quelle coinvolgenti i civili che ne rimasero vittima, in rapporto alla sua natura di “azione di guerra”. Le azioni predette sono purtroppo per loro natura caratterizzate da effetti consimili, come emerge dal “bombardamento” disciplinato dal Titolo II, Capo II Sez. II della legislazione di guerra di cui al R.D. n. 1415 del 1938, all. A. 7) Esclusa così la configurabilità del reato di strage contestato, il provvedimento d’archiviazione impugnato, abnorme, può essere riportato a legalità sostituendosi, a quella parte nella quale si dichiara la responsabilità dei denunciati per il reato predetto e si motiva l’archiviazione sulla base dell’amnistia disposta con d.lgs. lgt. 5 aprile 1944, n. 96, la motivazione inerente alla non previsione del fatto come reato dalla legge. - Omissis. ▲ IL COMMENTO di Ettore Gallo La questione di legittimità costituzionale Si tratta di una sentenza rigorosa, limpida, serena, estesa senza l’ombra di polemica, né nei confronti delle tesi dei pubblici ministeri, né nei riguardi delle allegazioni delle parti. È un ragionamento strettamente conseguenziale, che sembra guidare quietamente la mente del lettore a quella soluzione di giustizia, che diversa non poteva essere per coloro che hanno scelto, come dovere quotidiano, il difficile compito del giudicare. E, invece, non erano né pochi né semplici i problemi che la Corte doveva risolvere. E innanzitutto quello fondamentale che legittimava il ricorso stesso, la decisione, cioè, sulla dedotta abnormità del provvedimento impugnato, dalla quale soltanto dipendeva la ricorribilità in cassazione. Poche righe estremamente significative portano all’annullamento. Il provvedimento di archiviazione che, per l’art. 409 c.p.p., doveva essere emesso nelle forme del decreto, non solo è qualificato “ordinanza” ma, per di più, “ha il taglio motivazionale tipico della sentenza”. Il giudice degli atti preliminari, infatti, è entrato nel merito - annota la Corte - e ha condotto “uno specifico accertamento in malam partem nei riguardi di persone nei cui confronti l’azione penale non era stata esercitata”. Per ben sei pagine è stato ricostruito il fatto e il ruolo in esso svolto dai tre ricorrenti, qualificando il fatto stesso come delitto di strage. “Lo schema - si osserva - è quello previsto dall’art. 129 c.p.p., del quale il G.i.p. stesso aveva riconosciuto (a p. 35) l’inapplicabilità alla fase delle indagini”. Di conseguenza, aderendo all’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza 12 febbraio 1998, n. 17, Di Battista), la I Sezione penale della Corte di cassazione conviene sulla denunzia di abnormità del provvedimento “perché la natura neutra del decreto di archiviazione, emesso in una fase in cui gli elementi relativi alla notizia di reato sono ancora amorfi e fluidi, è radicalmente incompatibile con la dichiarata e motivata attribuzione di un reato ad un determinato soggetto”. A questo punto, però, la Corte ritiene si debba proporre e risolvere la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla difesa con atto successivo ai motivi di ricorso, e presentata nell’imminenza della decisione in Camera di Consiglio. È il solo punto questo su cui dobbiamo esprimere il nostro sommesso dissenso. Afferma la Corte, infatti, che l’eccezione proposta sarebbe irrilevante, e al tempo stesso manifestamente infondata, perché “gli artt. 408-411 c.p.p. non danno spazio per valutazioni concernenti in positivo la responsabilità dell’indagato per un reato determinato, accompagnate dall’archiviazione della notitia criminis relativa, e non può profilarsi, né si profila nel caso di specie, la lesione dei diritti e degli interessi lamentata in conseguenza di un provvedimento che, in quanto abnorme (corsivo nostro) è ricorribile in sede di legittimità e che deve essere annullato”. Evidentemente c’è stato un grave fraintendimento dell’eccezione sollevata dalla difesa, di cui riportiamo il testo: I. - Voglia la Corte Suprema Ecc.ma sollevare innanzi alla Corte costituzionale l’illegittimità dell’art. 411 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 1° comma, 24, 2° comma e 112, 2° comma, Cost. per la parte in cui applica le disposizioni di cui all’art. 409, 1° comma, c.p.p., e quindi consente l’archiviazione degli atti, anche nel caso in cui l’applicazione dell’amnistia sia subordinata ad un procedimento giurisdizionale di accertamento costitutivo nel quale la valutazione della sussistenza in fatto di determinate circostanze (nella specie la particolare finalità patriottica del fatto) e del loro valore rappresenta l’intervento necessario ed inderogabile della scienza e della volontà del giudice che contribuisce a rendere concreta ed effettiva la realtà estintiva astrattamente delineata dal legislatore. Non si tratta, perciò, di un’attività meramente dichiarativa dell’accertamento come nelle ipotesi in cui l’amnistia viene applicata de plano e ipso iure, ma di una complessa operazione che non può non concludersi con la sentenza di cui all’art. 129, 1° comma, c.p.p. Altrimenti si determinerebbe lesione del principio di eguaglianza fra i cittadini che, godendo del procedimento di cui all’art. 129 c.p.p., sono ammessi a dimostrare l’esistenza delle condizioni di cui al 2° comma dello stesso articolo, e perciò ad ottenere eventualmente una sentenza di assoluzione o di improcedibilità, e ad impugnare, se del caso, la sentenza stessa (così garantendo loro l’osservanza del diritto inviolabile di difesa e quello di ricorribilità contro la sentenza), a fronte di coloro che di tutti tali diritti e facoltà resterebbero privati da un sommario procedimento di archiviazione, che però motiva il suo aspetto decisorio proprio con l’apodittica affermazione che il presunto reato (peraltro mai contestato), integrato dal fatto per cui si è largamente indagato, sarebbe estinto dall’amnistia. Un procedimento sommario di archiviazione che al più potrebbe essere consentito nell’ipotesi in cui l’amnistia fosse già stata in precedenza applicata nelle forme di legge, oppure - come si è detto - ove apparisse applicabile de plano ed ipso iure senza alcun intervento di una valutazione di accertamento costitutivo da parte del giudice. Ragion per cui probabilmente il legislatore non ha ritenuto di includere né la fattispecie di amnistia (né quella concernente il fatto non preveduto dalla legge come reato) fra le cause legittimanti l’adozione di un provvedimento di archiviazione. II. - Sicché l’illegittimità costituzionale dell’art. 411 c.p.p. si prospetta altresì sotto il profilo della violazione dell’art. 2 n. 50 della legge delega del 1987, che prevede la possibilità dell’archiviazione unicamente per manifesta infondatezza della notizia di reato, per essere ignoti gli autori dello stesso o per improcedibilità dell’azione penale. La discrasia è tanto più evidente in quanto, invece, le due predette fattispecie sono testualmente richiamate nella direttiva 52 fra i casi per i quali può essere pronunziata sentenza di non doversi procedere, a’ sensi dell’art. 425 c.p.p., così come modificato dalla l. 8 aprile 1993, n. 105. Né può avere pregio il tentativo di parte della dottrina (ma si veda, in contrario, fra gli altri, e proprio con riferimento all’ipotesi dell’estinzione del reato, M. Chiavario, La riforma de processo penale, Torino, 1988, 100) di parlare di comprensibile estensione, da parte dell’art. 411 c.p.p., dei casi previsti dalla legge delega, in quanto resterebbe parimenti ingiustificabile che il p.m., una volta constatata l’esistenza di una causa estintiva, dovesse ugualmente esercitare l’azione penale, formulando l’imputazione e richiedendo il rinvio a giudizio. Questo rilievo, infatti, potrebbe valere esclusivamente per le altre ipotesi che abbiamo accennato, ma non quando l’applicazione dell’amnistia richiede un intervento giurisdizionale di accertamento costitutivo da parte del giudice, cui il p.m. non può sostituire la sua personale opinione, e nemmeno il giudice dell’archiviazione, che non può sostituire i suoi decreti o le sue ordinanze alla sentenza di cui all’art. 129 c.p.p. E ben questo sembra lo spirito che ha ispirato il legislatore ad escludere comunque che si possa procedere ad archiviazione quando ricorrano le due fattispecie che l’art. 2, n. 50, infatti, non richiama. Si benigni la Corte Ecc.ma di ritenere che ambo i profili d’illegittimità costituzionale così prospettati non sono “manifestamente infondati”. Appare prima facie evidente che l’eccezione sollevata ha valore assolutamente subordinato rispetto al motivo principale riguardante l’abnormità del provvedimento del G.i.p. È solare, infatti, che, dichiarata l’abnormità ed annullato il provvedimento, né alla difesa né ad altra parte in causa poteva più interessare il problema sollevato, ai fini della decisione della questione principale: e tanto meno alla Corte una volta che la decideva per altre ragioni e, fra l’altro, proprio nei sensi auspicati dalla difesa. Dice bene la sentenza che la lesione lamentata nell’eccezione di legittimità costituzionale non può profilarsi in conseguenza di un provvedimento abnorme, come tale ricorribile in sede di legittimità, dove dev’essere annullato. Ma i difensori non avevano virtù divinatorie, e perciò non potevano essere certi, nel momento in cui sollevavano l’eccezione, che la Corte avrebbe effettivamente giudicato abnorme il provvedimento del G.i.p. e l’avrebbe annullato. La prima obiezione, pertanto, riguarda la natura del provvedimento che si sarebbe dovuto adottare in vista del carattere assolutamente subordinato dell’eccezione. La Corte si sarebbe dovuta limitare a dare atto che la sollevata questione restava assorbita dall’accoglimento del motivo principale, oppure che il predetto accoglimento determinava il “non luogo a deliberare” sulla subordinata questione di legittimità costituzionale. Per il resto, poi, è evidente che la difesa aveva sostenuto, sollevando l’eccezione, proprio ciò che esattamente la Corte afferma. Sul merito del problema, insomma, c’era un perfetto accordo perché in realtà - se non viene fraintesa - la motivazione della questione lamenta esattamente quanto la Corte rileva. E dobbiamo anzi dire che, da parte nostra, abbiamo insistito nel chiarire l’equivoco che è al fondo di questa vicenda, proprio perché il problema, che è così emerso, è tuttora presente a turbare un punto non trascurabile del diritto processuale penale. Una questione di diritto processuale penale tuttora irrisolta Risulta sia dalla Relazione al Progetto preliminare, sia dai Lavori preparatori che, mediante le disposizioni di cui agli artt. 408-409 e 411 si è inteso ▲ G GIURISPRUDENZA Decisioni commentate 742 DIRITTO PENALE E PROCESSO n. 6/1999 G GIURISPRUDENZA Decisioni commentate 743 DIRITTO PENALE E PROCESSO n. 6/1999 estendere anche all’area degli atti preliminari quella sollecitudine che il legislatore suggerisce al p.m. allorquando viene a trovarsi, in ogni stato e grado del processo, innanzi a situazioni che manifestamente impediscono l’ulteriore corso del procedere: rendendo, perciò, inutile - anche per ragioni di economia processuale - far attendere al cittadino una soluzione di giustizia che, oltre tutto, gli è dovuta. L’esigenza di una espressa estensione derivava poi dal fatto che il nuovo codice distingueva nettamente le due fasi: da una parte, il “procedimento” per gli atti preliminari, e dall’altra il “processo”, per l’ulteriore corso dopo l’avvenuta formulazione dell’imputazione, rendeva difficile ottenere l’estensione mediante operazione di applicazione analogica. E tuttavia qualche differenza è rimasta fra le due serie di provvedimenti dell’una e dell’altra fase. Intanto, il mezzo processuale utilizzabile, in ovvia stretta dipendenza con la natura della diversa fase, giacché per quella degli atti preliminari è sufficiente il decreto motivato (artt. 409 p.p. - 410 comma 2 c.p.p.) mentre, per la fase del processo, il codice esige rigorosamente la sentenza del giudice (art. 129 p.p. c.p.p.). Altre differenze, pure dipendenti dalla diversa natura della fase processuale, riguardano le cause per le quali è possibile disporre l’archiviazione. Infatti, all’interno del vero e proprio processo, dispone l’art. 129 comma 1 c.p.p., che, in ogni stato e grado, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. Come è ben noto, poi, nel secondo comma sono disciplinate tutte quelle situazioni di maggior favore per l’imputato, fra quelle sopradescritte, che devono prevalere sulla causa di estinzione del reato qualora risultino già evidenti dagli atti. In tal caso, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta. Dunque, proprio perché qui siamo all’interno di un processo giurisdizionale che si conclude con sentenza, le possibilità di definizione da parte del giudice sono totali, e perciò si estendono anche ad ipotesi che il G.i.p. non potrebbe mai prendere in considerazione. Come accade per il rapporto fra la condotta dell’imputato e il fatto (l’imputato non lo ha commesso) oppure per la non qualificazione del fatto (fatto non costituisce reato) o per l’esistenza stessa del fatto (fatto non sussiste). Nella fase degli atti preliminari, invece, è innanzitutto l’infondatezza della notitia criminis che viene in esame (art. 408 c.p.p.). Ad altre ipotesi poi è l’art. 411 c.p.p. che estende l’archiviazione, non sempre però in ortodossa osservanza della delega. Dice, infatti, questo articolo che le disposizioni degli artt. 408-409 e 410 (decreto motivato od ordinanza di archiviazione) si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità (e cioè: la querela, l’istanza, la richiesta o l’autorizzazione a procedere) o che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ora, sia per dottrina che per giurisprudenza, si è talvolta ritenuto ragionevole il ricorso all’istituto dell’archiviazione anche nelle ipotesi aggiunte dall’art. 411 c.p.p. perché - si è detto - già sotto l’impero del codice abrogato si era instaurata la stessa prassi (1). In realtà, l’art. 378 c.p.p. abrogato era, invece, rigoroso nel prescrivere espressamente in detti casi la sentenza di proscioglimento, e d’altra parte anche la dottrina che indulgeva a quella prassi, lo faceva con molta prudenza e sotto precise condizioni (2). Il vero è che, quando si allude a quella certa prassi in tema di “estinzione del reato”, che è quanto qui interessa, si pensa all’ipotesi di “accertamento mero”, dove il giudice applica “de plano” la causa di estinzione senza che occorrano né particolari indagini di non poco momento, né deduzioni scientifiche che implichino sequenze e correlazioni logiche. Estinguere il reato per la morte del reo, o perché è trascorso tutto il tempo che la legge prevede per la prescrizione, o infine perché si tratta soltanto di verificare che la qualificazione penalistica contemplata dalla legge estintiva sia proprio quella che riguarda il fatto storico da esaminare, non richiede alcuna lunga né particolare indagine né specifica deduzione logico-scientifica da parte del giudice. Ma se la legge che estingue il reato ha inserito particolari condizioni di applicazione, che costringono il giudice (o il p.m.) ad esaminare testimoni, ad accedere sui luoghi etc., ed alla fine a confrontare risultanze, favorevoli o contrarie, alle condizioni di applicazione poste dalla legge, non soltanto s’allungano i tempi che contrastano con la speditezza del processo, ma la stessa scienza del giudice entra nel giudizio, trasformando l’accertamento mero in accertamento costitutivo. In tal caso è proprio la ratio della diversa situazione che giustifica il venir meno di ogni possibile affidamento dell’operazione agli atti preliminari, mentre si rende indispensabile che il tutto sia presidiato dal contraddittorio delle parti, e che l’intervento conclusivo del giudice avvenga per sentenza impugnabile. Ebbene, non può essere senza ragione che già la legge delega del 1974, nell’art. 2 n. 41, avesse previsto l’archiviazione del procedimento soltanto per manifesta infondatezza della denuncia, della querela o dell’istanza: e che poi l’art. 2 n. 50 della legge delega del 1987 l’avesse estesa soltanto al caso degli autori ignoti e a quelli di improcedibilità dell’azione. Ma c’è di più. Infatti, per converso, la direttiva 52 menziona testualmente le due fattispecie di archiviazione per estinzione del reato, e perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, fra le ipotesi che vanno affidate a sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p. ▲ Note: (1) Cfr. Cass. 13 maggio 1985, Gnucci, in Giust. pen., 1986, II; 37; Cass. 13 ottobre 1982, Spinelli, in Riv. pen., 1983, 707; in dottrina v. A. Bernardi, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, (Speciali di Leg. pen.) IV, Torino, 1990, 543 e s. (2) La citazione che si fa di F. Cordero, voce Archiviazione, in Enc. dir., II, 1958, 1032, va, infatti, precisata rilevando che il consenso a far luogo all’archiviazione era dato subordinatamente al fatto che la superfluità del processo potesse essere accertata mediante un’indagine non incompatibile con l’esigenza di speditezza. Da tutto quanto fin qui detto emerge chiaramente che - come già rilevato - la difesa aveva sollevato l’eccezione di legittimità (per il caso in cui non fosse stato accolto il motivo principale di impugnazione) proprio perché lamentava quanto affermato dalla Corte di cassazione. E cioè, che la situazione di cui agli artt. 408-411, non dando alcuno “spazio per valutazioni concernenti in positivo la responsabilità dell’indagato per un reato determinato, accompagnato dalla archiviazione della notitia criminis relativa”, pregiudica gravemente i diritti fondamentali degli indagati. I quali, trattandosi di applicazione di amnistia a seguito di giudizio di accertamento costitutivo (in fatto, il p.m. - su richiesta del G.i.p. - aveva impiegato mesi per vincere, attraverso le indagini e gli esami testimoniali, l’accusa delle parti civili, secondo cui l’episodio non era sostenuto dai motivi patriottici contemplati dall’amnistia, ché, anzi, sarebbe stato determinato da sentimento di odio nei confronti dei patrioti appartenenti al movimento “bandiera rossa”) avrebbero dovuto perciò fruire dell’area del processo ed essere giudicati con sentenza. In tal caso, avrebbero potuto invocare il secondo comma dell’art. 129 c.p.p., sostenendo che il fatto non è previsto dalla legge come reato, e se il giudice avesse disatteso la tesi, avrebbero avuto a disposizione un’ordinaria impugnazione in sede di legittimità, anziché quella eccezionale, subordinata al riconoscimento dell’abnormità del provvedimento. Accanto a questo motivo, prevalentemente ispirato al 2° comma dell’art. 24 Cost., la difesa aveva coerentemente eccepito anche la violazione della legge delega (artt. 76 e 77 Cost.). Contro tale eccezione non poteva essere opposta la debole tesi secondo cui, però, sarebbe comunque giustificabile che il p.m. non avesse ad esercitare l’azione penale una volta riconosciuta l’esistenza di una causa estintiva. Al più il rilievo potrebbe valere per una causa estintiva applicabile de plano con decreto motivato, ma non certo a fronte dell’esigenza di un intervento giurisdizionale di accertamento costitutivo da parte del giudice, che necessariamente postula la formulazione dell’imputazione e la definizione del giudizio mediante sentenza (3). Si è trattato, dunque, di un travisamento interpretativo da parte della Corte, che dimostra, anzi, la permanenza del problema processuale che la difesa aveva in subordine prospettato con l’eccezione di legittimità costituzionale. Perché il fatto non era previsto dalla legge come reato Di grande interesse, invece, e assolutamente definitiva, tutta la parte che induce la Corte, riconosciuta l’abnormità del provvedimento di archiviazione del G.i.p., a sostituire in esso una causa diversa che ne ripristini la legalità. La motivazione ampia e rigorosa ha il merito di prendere posizione nei confronti della sentenza 20 luglio 1948, n. 631, del Tribunale militare di Roma (4), che, pur affermando la illegittimità della rappresaglia delle Fosse ardeatine per violazione del principio di proporzione, aveva tuttavia negato anche quella di “Via Rasella”, perché la natura clandestina del movimento partigiano non consentiva quei segni distintivi, visibili da lontano, che richiedeva l’art. 1 della Convenzione dell’Aja 18 ottobre 1907 (5). Per verità, quella sentenza era stata poi completamente ribaltata dalla successiva del Tribunale Supremo Militare 25 ottobre 1952, n. 1711 (6). In sostanza, la Corte di cassazione, da una parte - richiamando la già citata sentenza delle Sezioni Unite civili - nega conferenza, in relazione al fatto di Via Rasella, agli artt. 25 e 27 della legge italiana di guerra, “in quanto tali norme erano dirette solo a limitare i poteri dello Stato italiano nei confronti dei cittadini di altri Stati”, ovviamente in caso di occupazione italiana di territorio straniero. Dall’altra, pur riconoscendo che la questione non poteva essere risolta con riferimento al d.lgt. n. 194 del 1945 (in quanto si sarebbe dato effetto retroattivo al riconoscimento di “azione di guerra” che il detto decreto luogotenenziale comportava), rammentava che, dopo la dichiarazione di guerra alla Germania...
domenica 12 marzo 2023
Priamo ai piedi di Achille.
Solo nel libro XXIV dell’Iliade, che chiude l’intero poema, il ciclo delle distruzioni innescate dal contagio dell’ira ha finalmente il suo termine. Una notte, un Priamo insonne dal giorno della morte di Ettore si introduce di nascosto nella tenda di Achille, anch’egli prostrato da numerose veglie notturne, trascorse nel ricordo di Patroclo. Il vecchio bacia le giovani mani che hanno assassinato suo figlio e chiede al più forte/temibile dei suoi nemici un atto di umanità: la restituzione delle spoglie di Ettore, in cambio di numerosi e preziosi doni. Dopo un ultimo rigurgito dell’ira funesta che aveva fatto il suo esordio nel libro I, Achille cambia atteggiamento, perché avverte un sentimento che non aveva provato con tale intensità prima d’ora. Si tratta della tristezza, che riporta tutto nella sua giusta prospettiva.
Che cos’è ora la vendetta che Achille aveva considerato tanto desiderabile, durante il fuoco divampante dell’ira? Nient’altro che questo: un cumulo di cenere che aveva preso forma in un vecchio re caduto in ginocchio e in lacrime, per chiedergli indietro soltanto un cadavere.
Achille fa un passo indietro, quello che non aveva saputo fare quando subì torto da Agamennone, e consente la restituzione di Ettore. Il re può tornare nella sua reggia. Il morbo si spegne. Infine uomini e dèi si abbandonano, dopo tanto tribolare, al ristoro e al silenzio del sonno, che appare tanto più desiderabile dopo tanto caos e il rumore della mischia.
Dall’alba bruciante in cui Achille interroga Calcante alla notte di Priamo, la rabbia che divide gli uomini si dissolve gradualmente, per riaggregarsi nella solidarietà della tristezza.
Questa solidarietà che in molti oggi non alberga nei cuori e che sembrano assistere a situazioni tragiche o a condizioni misere di tanti esseri umani quasi con gioia e indifferenza.
Chi ha un comportamento di tal tipo è colmo di disumanità e ha una visione del mondo di sopraffazione su tanti esseri umani.
La nostra società ha bisogno di umanità!
Dobbiamo conquistare una visione nuova e diversa dei rapporti economico-sociali per mettere in condizione ogni essere umano di vivere nella libertà dai bisogni materiali e spirituali, nella fratellanza, dettata dai comuni interessi, dall’uguaglianza.
.
Omero, Iliade.
Libro XXIV
Priamo ai piedi di Achille.
..E, nei ricordi immersi, l’uno Ettore prode piangeva
dirottamente, steso dinanzi ai piedi d’Achille:
ed il Pelide anch’egli piangeva, or pensando a suo padre,
ora a Pàtroclo; e tutta suonava di pianto la casa...
Finiti i giochi funebri, tutti vanno a riposare, ma Achille piange ancora Patroclo; infierisce ancora sul cadavere di Ettore, facendogli fare tre giri attaccato al carro. Apollo è mosso a compassione di Ettore, e alla fine convince anche gli altri dei che è meglio che Achille renda il corpo di Ettore a suo padre Priamo. Giove perciò fa convocare Teti, per comunicarle questa decisione.
Fine ebbe allor la gara, si sparsero tutte le genti,
ciascuno alla sua nave. Pensarono gli altri alla mensa,
tutti, a godere il sonno soave. Soltanto il Pelide,
pensando al suo compagno diletto, piangeva, né il sonno
che tutti vince, lui vinceva. Qua, là, si voltava,
pensando il gran valore di Pàtroclo e il baldo coraggio,
e quante imprese aveva compiute, e dolori sofferti
con lui, guerre affrontando, solcando gl’infidi marosi.
Pensando a tutto ciò, versava amarissimo pianto,
ora giacendo sul fianco, volgendosi poscia supino,
poscia bocconi; e talora, levandosi in piedi, girava,
pieno di smania, lungo la spiaggia del mare. L’Aurora
non gli sfuggiva, però, quando il mare imbiancava alla spiaggia;
ma dopo avere al giogo costretti i veloci cavalli,
Ettore dietro al carro legava; e poiché trascinato
per tre volte l’avea di Pàtroclo intorno alla tomba,
di nuovo alla sua tenda tornava, ed il corpo lasciava
steso bocconi dentro la polvere. E Apòlline allora,
mosso a pietà dell’eroe, sebbene defunto, il suo corpo
d’ogni bruttura tergea, lo cingeva con l’ègida d’oro,
mentre ei lo trascinava, perché straziato non fosse.
Nella sua furia, cosi, strazio d’Ettore Achille faceva.
E n’ebbero pietà, vedendolo, i Numi d’Olimpo,
e invito all’Argicida facevan, perché lo involasse.
Fu tale avviso a tutti gradito; ma spiacque alla sposa
di Giove, e all’occhiazzurra Fanciulla, e al Signore del ponto:
serbavano essi l’ira concetta contro Ilio, ed il sire
Priamo, e la gente d’Ilio, per colpa di Pàride, quando
egli le Dive offese, venute a cercarlo all’ovile,
e quella esso prescelse che offerta gli fe’ del piacere.
Or, poi che da quel giorno spuntarono dodici aurore,
Apollo Febo queste parole rivolse ai Celesti:
«Tristi voi siete, o Dei, maligni: non v’arse abbastanza
Ettore un giorno cosce di bovi e di capre perfette?
Or non vi basta il cuore, neppur dopo morto, a salvarlo,
si che la sposa lo veda, lo vedano il figlio e la madre,
e Priamo il padre, e tutta la gente di Troia, che il corpo
presto arderebbero, e a lui renderebbero pubblici onori.
Ma sempre aiuto, o Numi, voi date al crudele Pelide,
che pur, viscere umane non ha, non ha cuore nel petto
che si commuova: egli ha d’un leone l’istinto selvaggio,
che, come lo consiglia l’intrepido cuore e l’immane
forza, sovresse le greggi s’avventa, per farne suo pasto:
similemente, Achille pietà non ha più, né ritegno
che pei mortali è fonte di mali ed è fonte di beni.
Altri, sovente, persona più cara perde’ d’un amico,
od un fratello nato da un grembo medesimo, o un figlio,
eppur, quando esso ha pianto, gemuto, si placa alla fine:
ché paziente cuore concesser le Parche ai mortali;
Ma questi, sempre al carro legato trascina il divino
Ettore, al carro stretto, di Pàtroclo intorno alla tomba;
e questo scempio, a lui non giova, né onore gli rende.
Badi che l’ira nostra su lui, benché prode, non piombi:
ché terra muta è quella ch’ei va furioso oltraggiando».
Era crucciata rispose, la Diva dall’omero bianco:
«Certo diresti bene, signore dall’arco d’argento,
se ad Ettore e al Pelide voi date il medesimo onore;
ma Ettore è mortale, succhiò d’una femmina il latte,
e Achille è d’una Dea figliuolo, ch’io stesso allevai,
io nutricai, la diedi consorte ad un uomo mortale,
Pelèo, tanto ai Celesti diletto. E voi tutti alle nozze
foste presenti, o Numi. Tu pur banchettavi fra loro,
con la tua cetra, o tu amico dei tristi, o tu sempre malfido».
E a lei di Crono il figlio, che i nugoli aduna, rispose:
«Era, non ti crucciare cosí contro tutti i Celesti.
Uguale non sarà d’entrambi l’onore. Ma caro
Ettore anch’egli fu su tutti i Troiani ai Celesti,
caro a me fu; ché privo non mai mi lasciò dei miei doni:
mai vuota l’ara mia non restò della debita parte
di libagioni e d’ostie: ché questo è l’onor che ci spetta.
Ora io consentirò che d’Ettore ardito la salma
venga sottratta ad Achille. Ma far non si può di nascosto,
ché presso notte e giorno sua madre a lui resta, e lo assiste.
Ma su, qualcun di voi dica a Teti che venga a me presso,
perché da me riceva un saggio consiglio: che Achille
doni da Priamo accetti, disciolga dal carro il suo figlio».
Iride va a chiamare Teti, e Teti corre presso Achille per convincerlo ad accettare i doni che gli porterà Priamo e a cedere il corpo di Ettore. Achille accetta.
Cosí diceva. Ed Iri, la diva dal pie’ di procella,
corse a recare il messaggio. Tra Samo ed Imbro rocciosa,
giù negli abissi balzò del pelago, simile a un piombo
che, penduta dal corno d’un bove selvatico, scende
giù giù nel mare, ai pesci voraci recando la morte.
E Tètide trovò dentro un concavo speco; e d’intorno
stavano l’altre Dive del pelago; ed essa, nel mezzo,
del puro suo figliuolo piangeva il destino, che morte
trovar doveva in Troia ferace lontan dalla patria.
Iri dai pie’ veloci vicina le stette, e le disse:
«Tètide, sorgi! Giove ti chiama, il supremo dei Numi!».
E Tèti a lei rispose, la Dea dall’argenteo piede:
«Perché dunque mi chiama, quel Nume possente? Ho ritegno
di mescolarmi ai Numi, ch’io soffro dolori infiniti.
Ma pure, andrò; né vana sarà la parola ch’ei disse».
Detto cosi, la Dea fra le Dive, si cinse d’un velo
bruno, che veste alcuna non c’era più bruna di quella,
e mosse. Ed Iri innanzi, la Diva dai piedi di vento,
erale guida; e d’attorno s’aprivano i flutti del mare.
Sopra la spiaggia poi venute, balzarono al cielo.
L’onniveggente Cronide trovarono; e tutti d’intorno
stavano gli altri Numi raccolti, che vivono eterni.
Atena il posto allora cedette; e sede’ presso Giove
Tètide; ed Era offerta le fece d’un calice d’oro,
cortese le parlò. Bevve Tèti, poi rese la coppa.
E allora favellò degli uomini il padre e dei Numi:
«Tètide, tu sei giunta, sebbene crucciata, all’Olimpo,
inconsolabile doglia chiudendo nel cuor, lo so bene.
Ma tuttavia, ti dirò perché qui t’ho fatta chiamare.
Da nove giorni è sorto contrasto fra i Numi immortali.
D’Ettore n’è cagione la salma, ed Achille Pelide.
Alcuni all’Argicida chiedevan che il corpo involasse;
ma io ben altro vanto concedere voglio ad Achille,
ché l’amicizia sua, l’amor, vo’ che sempre mi resti.
Sùbito al campo va’, tal mònito reca a tuo figlio:
che sono irati i Celesti, ed io più di tutti i Celèsti
sono sdegnato, perché, nella furia che il cuore gl’invade,
non scioglie Ettore, e presso le concave navi lo tiene.
Vedi s’egli abbia di me reverenza, se Ettore sciolga.
Ed Iri manderò, che al magnanimo Priamo imponga
recarsi ai curvi legni d’Acaia a disciogliere il figlio,
doni ad Achille recando che possano il cuore blandirgli».
Disse cosi. Né fu tarda la Dea dall’argenteo piede,
ma con un balzo, giù s’avventò dalle cime d’Olimpo,
giunse alla tenda del figlio. Gemeva e piangeva il Pelide
dirottamente; e a lui d’intorno, i diletti compagni
erano tutti in faccende, la cena apprestando: immolata
entro la tenda una pecora avevano grande villosa.
A lui sede’ vicino vicino la madre divina,
gli fece una carezza, lo chiamò per nome, gli disse:
«0 figlio mio, sino a quando, gemendo cosi, dolorando,
il cuor ti roderai, senza al cibo pensar, né all’amore?
Con una donna è pure soave allacciarsi in amore:
ché non mi camperai troppo a lungo, figliuolo, ma presto
saranno sopra te la Morte ed il Fato possente.
Ma presto dammi retta, ché io giungo aralda di Giove.
Dice che i Numi sono crucciati e più ancora dei Numi,
egli è sdegnato, perché nella furia che il cuore t’invade,
non sciogli Ettore, e presso le concave navi lo tieni.
Su via, scioglilo, e accetta pel corpo defunto il riscatto».
E Achille, eroe dai piedi veloci, cosí le rispose:
«E sia cosi. Compensi mi rechi, e il cadavere prenda,
se veramente questo desidera e impone il Cronide».
Entro il recinto cos! delle navi, la madre e il figliuolo
stavano l’un con l’altro scambiando veloci parole.
Giove manda Iride da Priamo per dirgli di andare a riscattare il corpo di Ettore. Priamo si consulta con sua moglie Ecuba, che teme per la sua vita. Ma lui vuole partire; prepara i doni per Achille e dice ai figli di metterli sul carro.
E Giove Iri riandò, la Dea velocissima, a Troia:
«Iri veloce, va’, le vette d’Olimpo abbandona,
e, giunta ad Ilio, Priamo cuore magnanimo, esorta
che vada ai curvi legni d’Acaia, e riscatti suo figlio,
doni ad Achille recando che possano il cuore blandirgli;
e solo vada, e niuno con lui dei Troiani si rechi.
Solo un araldo vada più vecchio di lui, che i muletti
guidi, ed il carro di ruote veloci, e di nuovo alla rocca
rechi di Troia il corpo che Achille Pelide trafisse.
Né della morte accolga timore, né d’altro malanno:
tale un compagno a lui darò: l’Argicida, che guida
gli sia, finché non l’abbia condotto vicino ad Achille.
E poi ch’entro la tenda condotto l’avrà, né il Pelide
il veglio ucciderà, né ch’altri gli rechi alcun danno
consentirà: ché sciocco non è, né imprudente, né empio:
ogni rispetto avrà dell’uomo che supplice piange».
Disse. E al messaggio balzò la Diva dai pie’ di procella
e giunse a Priamo. E qui trovò solo pianto e lamento.
D’intorno al padre, i figli sedevano dentro la corte,
bagnavano di pianto le vesti; e fra loro il vegliardo
tutto ravvolto stava, nascosto nel manto; e bruttava
molta lordura il collo, la testa del vecchio: egli stesso
con le sue mani raccolta l’avea, voltolandosi a terra.
E per la casa, le figlie, le suore, levavano pianto,
per la memoria dei loro diletti, che molti, che prodi,
giacean caduti, spenti per man degli argivi guerrieri.
Vicina a Priamo stette di Giove l’aralda, e parole
gli volse a bassa voce: d’un trèmito il vecchio fu còlto.
«Fa’ cuore, Priamo figlio di Dàrdano. A che ti sgomenti?
Non vengo io qui per danno ch’io veda che debba seguirti,
ma cerco il bene tuo. Di Giove io ti reco un messaggio,
che ha cura e pietà di te, benché tu sei lontano.
T’impone ora l’Olimpio che Ettore a scioglier tu vada,
doni ad Achille recando che possano il cuore blandirgli,
e solo vada, e niuno con te dei Troiani si rechi.
Solo un araldo venga più vecchio di te, che i muletti
guidi, ed il carro di ruote veloci, e di nuovo alla rocca
porti di Troia il corpo che Achille Pelide trafisse.
Né te di morte colga timore, né d’altro malanno:
tale un compagno a te darà: l’Argicida, che guida
ti sia, finché condotto non t’abbia vicino ad Achille.
E poi ch’entro la tenda condotto t’avrà, né il Pelide
a te morte darà, né ch’altri alcun danno ti rechi
consentirà: ché sciocco non è, né imprudente né empio:
ogni rispetto avrà d’un uomo che supplice giunge».
Detto cosi, parti la Diva dai piedi veloci.
Ed esso ai figli impose che un carro da muli veloce
mettessero in arnese, ponesser sovra esso una cesta.
Ed egli poi discese nel talamo tutto fragrante,
alto, di legno di cedro, che molti chiudeva tesori,
ed Ecuba chiamò, la diletta sua sposa, e le disse:
«0 poverina, da parte di Giove me giunto un messaggio,
ch’io degli Achivi ai legni mi rechi e riscatti il figliuolo,
doni ad Achille recando che possano il cuore blandirgli.
Or questo di’: che cosa ti par che decidere io debba?
Per me, troppo la brama, la smania che m’arde, mi spinge
ch’io nell’esteso campo d’Acaia alle navi mi rechi».
Si disse. E in pianto ruppe la donna, e cosí gli rispose:
«Ahimè!, dove il tuo senno svaní, che pur celebre un giorno
te fra gli estranii rese, fra quei che ti chiamano sire?
Andar come vuoi tu soletto alle navi d’Acaia,
andare sotto gli occhi dell’uomo che tanti figliuoli
giovani e prodi t’uccise? Davvero, il tuo cuore è di ferro!
Ché s’ei ti piglierà, non appena ti avrà sotto gli occhi,
crudo ed infido qual’è, di te non avrà compassione,
rispetto non avrà. Piangiamolo, via, da lontano,
restando entro la casa: ché quando lo diedi alla luce,
per lui fiero Destino tal sorte segnò, ch’ei dovesse
sfamare i pronti cani, lontano dai suoi genitori,
presso ad un uomo feroce. Il fegato a mezzo azzannargli
potessi, e divorarlo! Compiuta così la vendetta
del figlio mio sarebbe. Ché questi non cadde da vile,
ma pei Troiani pugnò, per le femmine belle troiane,
senza che a fuga pensasse, pensasse a schivare la morte».
E il vecchio Priamo a lei rispose con queste parole:
«Non trattenermi quand’io voglio andare, non fare l’uccello
del malaugurio in casa, ché già, non puoi farmi convinto.
Se consigliato a me l’avesse qualcun dei mortali,
quanti indovini, sono, o aruspici, oppur sacerdoti,
creder potremmo a un inganno, staccarci dai loro consigli;
ma or ch’io stesso ho udita la Dea, con questi occhi l’ho vista,
andrò, né invano avrà parlato; e se vuole il destino
ch’io muoia presso ai legni d’Acaia, a morire son pronto:
subitamente Achille m’uccida, quando io tra le braccia
stretto abbia pur mio figlio, sfogata la brama del pianto».
Cosí disse; e i coperchi dischiuse dei cofani belli.
Di qui dodici pepli, fra tutti i più belli, trascelse,
con dodici mantelli d’un doppio, e altrettanti tappeti,
dodici manti grandi, con dodici tuniche; ed oro
su la bilancia pose, ne prese ben dieci talenti,
e due tripodi, tutti fulgenti, con quattro lebèti,
e una bellissima tazza che data g’i avevano i Traci,
un di che ad essi ei giunse messaggio; e valeva un tesoro;
ma neppur questa volle serbare il vegliardo: tal brama
avea di riscattare suo figliolo. E scacciò dalla corte
tutti i Troiani; e ad essi rivolse parole d’oltraggio;
«Andate via di qui, svergognati importuni! Vi manca
forse da piangere a casa, che qui mi venite a crucciare?
O non vi basta forse che Giove mi die’ questo strazio
che il figlio mio perdessi, che era fra tutti il più prode?
Ben presto lo dovrete sapere anche voi: ché agli Atridi
preda sarete, adesso ch’è spento, più agevole molto.
Ma io prima che debba veder con questi occhi distrutta
e messa Troia a sacco, vo’ scendere ai regni d’Averno».
Dicea cosi, con lo scettro facendosi largo; e la turba
usci dinanzi al vecchio che andava di furia. Ed ai figli
questi die’ un grido, ad Èleno, a Paride, al divo Agatone,
a Pàmmore, ad Antifone, prode guerriero, a Polite,
a Deifobo, a Divo mirabil di forme, ad Ippòte.
A questi nove il vecchio die’ ordini, alzando la voce:
«Tristi figliuoli, infingardi, sbrigatevi, su! Deh, se invece
d’Ettore, tutti voi foste morti vicino alle navi!
Oh, poveretto me, che diedi alla vita figliuoli
nell’ampia Troia insigni, né in vita pur uno è rimasto,
Mèstore simile ai Numi, e Tròilo, signor di segugi,
ed Ettore, che un Dio parea tra i mortali, che figlio
no, non pareva d’un uomo mortale, bensí d’un Celeste.
Marte li uccise tutti, sol restano questi codardi.
tutti menzogna e balli, ché sono maestri a danzare,
maestri a fare preda, fra il popol, d’agnelli e capretti.
Non vi volefe dunque sbrigare? Allestitemi il cocchio,
e tutta questa roba metteteci: io debbo affrettarmi».
Disse cosi. Sbigottiti pei gridi del padre, i figliuoli
trassero fuori il carro da muli di ruota veloce,
bello, costrutto da poco, sovr’esso legarono il cesto.
Via dal puntello poscia sfilarono il giogo da muli,
umbilicato, bello, provvisto d’un duplice anello,
e insiem trasser la cinghia del giogo, che avea nove braccia.
Poscia, sul ben levigato timone posarono il giogo,
sopra la punta estrema, il cerchio infilar nel puntale,
su l’umbilico tre volte legaron da entrambe le parti
la cinghia, in tutto punto, piegarono indietro il fermaglio.
Poscia, dal talamo fuori recato il riscatto infinito
d’Ettore, sopra il carro lucente lo posero, e al giogo
strinsero i muli poi, gagliardi, dall’unghia robusta,
che a Priamo un giorno i Misii recarono, doni fulgenti.
Quindi i cavalli per Priamo legarono al giogo che il vecchio
solea di propria mano nutrir nella fulgida greppia.
Nella dimora eccelsa facevano i carri aggiogare
cosi Priamo e l’araldo, assorti nei gravi pensieri.
Ecuba dice al marito di offrire libagiorni e preghiere a Giove. Giove fa apparire un’aquila come segno di buon auspicio, e Priamo allora parte.
Ed ecco, presso a loro si fece, col cuore crucciato,
Ècuba; e vin più dolce del miele in un calice d’oro
con le sue mani offrì, ché libassero pria di partire.
Stette dinanzi ai cavalli, parlò queste alate parole:
«Tieni, ed a Giove liba, perché dalle genti nemiche,
tornar ti faccia a casa, se pur ti sospinge il tuo cuore
che tu vada alle navi d’Acaia, per quanto io non voglia.
Su via, la prece volgi a Giove che i nuvoli aduna,
ch’abita I’Ida, e Troia col guardo suo domina tutta,
e chiedi a lui che, pronto messaggio, egli l’aquila mandi,
che prediletta da lui, fra tutti i pennuti il più forte,
e che da destra la invii, ché bene tu possa vederla,
e, confidando in lui, raggiunga le navi d’Acaia.
Ché poi, se non vorrà l’auspicio accordarti il Cronide,
davvero io non potrei consigliare che tu t’avviassi
verso le navi argive, per brama che tu possa averne».
E a lei Priamo cosi, che un Nume sembrava, rispose:
«Al tuo consiglio, o donna, restio non voglio essere: a Giove
le mani alzare è bene, ch’egli abbia di me compassione».
Alla dispensiera, ciò detto, diede ordine il vecchio
ch’acqua purissima sopra le mani versasse. Ed apparve
presto l’ancella, e in mano reggeva un catino e una brocca.
E Priamo si lavò, poi chiese alla sposa la coppa,
e, stando in mezzo all’atrio, al cielo volgendo lo sguardo,
libò purpureo vino, le labbra alla prece dischiuse:
«O Giove re, signore dell’Ida possente ed illustre,
fa che ad Achille io giunga diletto, e a pietà lo commuova;
e a me l’aquila manda, veloce messaggio, diletto
a te su quanti sono pennuti, e fra tutti il più forte,
e mandalo da destra, ché bene io lo possa vedere,
e, confidando in lui, raggiunga le navi d’Acaia».
Cosí dicea pregando. L’udí l’alto senno di Giove,
e l’aquila mandò, perfetta fra tutti gli alati,
la cacciatrice, bruna di penne, cui chiamano fosca.
Quanto è grande la porta di duplice imposta, ben chiusa,
del talamo dall’alto soffitto d’un uomo opulento,
tanto eran grandi l’ali da un lato e dall’altro. Ed apparve
lanciandosi da destra sopra Ilio. Gioirono tutti,
come la videro, a tutti s’effuse conforto nel cuore.
E il vecchio in tutta fretta salì sopra il lucido cocchio,
e spinse il carro fuori dal portico e l’atrio sonoro.
Ivano innanzi dunque le mule, e tiravano il carro
di quattro ruote: Idèo lo guidava, Io scaltro; e i cavalli
ivano dietro, che il vecchio spingea con la sferza a gran possa,
traverso la città: seguivano tutti i suoi cari,
dirottamente piangendo, cosí come andasse alla morte.
Giove manda Hermes a proteggere Priamo durante il viaggio. Ermes si presenta a lui come un mirmidone e si offre di scortarlo.
E poi che, dunque, usciti da Troia, pervennero al piano,
i generi ed i figli, di nuovo rivolto il cammino,
tornarono in città. Ma i due non sfuggirono a Giove,
come comparvero al piano. Li vide, e pietà del vegliardo
ebbe, e a suo figlio Ermète si volse con queste parole:
«Ermète, o tu che godi, fra tutti i Celesti, compagno
farti dell’uomo, e ascolti, se alcuno li chiami, e se vuoi,
muovi ora, e Priamo adduci vicino alle navi d’Acaia,
cosi che niuno possa vederlo né averne sentore
degli altri Dànai, prima che giunga vicino al Pelide».
Disse; né tardo fu l’Argicida che l’anime guida.
Sùbito sotto le piante si strinse i leggiadri calzari
d’oro, immortali, che via lo rapivan su l’umido gorgo,
via per l’intermine terra, insieme coi soffi del vento:
anche la verga prese, onde gli occhi degli uomini sfiora,
questi, se vuol sopirli, se dormono questi, a destarli:
quella stringendo in pugno, volava il gagliardo Argicida.
A Troia, all’Ellesponto cosí rapidissimo giunse;
e mosse, e avea l’aspetto di giovane principe, quando
gli ombra le gote la prima pelurie, e più fulgono gli anni.
Or, come furono d’Ilio passati oltre il tumulo grande,
quivi i cavalli ed i midi fermar su le rive del fiume,
per beverarli; e già su la terra sceso era il tramonto.
E allor, vide l’araldo, s’accorse, scorgendolo presso,
d’Ermète; e a Priamo tosto si volse con queste.parole:
«Figlio di Dàrdano, attento; ché vigile mente ora occorre:
io vedo un uomo; e temo che presto c’infligga la morte.
Su via, dunque, fuggiamo coi nostri cavalli, o cadiamo
dinanzi ai suoi ginocchi, se avesse di noi compassione».
Qui si turbò la mente del vecchio, e lo invase terrore:
sopra le curve membra d’orror s’arricciarono i peli,
e sbigottito stette. Ma presso gli venne il Benigno,
le mani prese al vecchio, gli volse cosí la parola:
«0 padre, dove spingi cosí le tue mule e i cavalli
per la divina notte? Già dormono tutti i mortali.
Timore tu non hai dei feroci guerrieri d’Acaia,
che son vicini a te, che t’odiano e son tuoi nemici?
Se nella notte negra veloce qualcuno ti vede,
portar tanta ricchezza, che cosa tu fare potresti?
Giovine tu non sei più, troppo vecchio è costui che ti segue,
per tener fronte ad un uomo, se primo venisse a investirvi.
Ma io farti non vo’ nessun male; e se altri t’assalta,
dare ti vo’ soccorso: ché tu rassomigli a mio padre».
E a lui rispose allora con queste parole il vegliardo:
«E tutto vero quello che dici, figliuolo diletto;
ma sopra noi la mano tien pure qualcun dei Celesti,
che in tale viatore mi diede ch’io qui m’imbattessi,
quale tu sei, benigno, mirabil di viso e d’aspetto;
e saggio sei di mente, figliuolo di genti beate».
E l’Argicida a lui rispose che l’anime guida:
«Si, le parole che dici son tutte opportune, buon vecchio:
ma questo ancora dimmi, rispondimi senza menzogna:
tanti tesori si belli, li rechi tu forse lontano,
presso straniere genti, ché lì ti rimangan sicuri,
oppur la sacna Troia lasciate oramai tutti quanti,
per il timore, perché spento è l’uomo più prode di tutti,
il figlio tuo? Ché certo non era egli scarso alla guerra».
E il vecchio Priamo a lui rispose con queste parole:
«O buono, e chi sei tu? Da che genitori sei nato?
Con che dolcezza parli del mio sventurato figliuolo!».
E l’Argicida a lui rispose, che l’anime guida:
«D’Ettore divo tu mi chiedi, buon vecchio, e mi tenti:
io molte volte, nella battaglia che prova le genti,
l’ho con questi occhi veduto, quando egli, spingendo alle navi
gli Achei, li sterminava, struggeva, col lucido bronzo.
Ad ammirarlo noi stavamo; ché in collera Achille
contro l’Atride, a noi proibiva che andassimo a zuffa:
ch’io suo scudiere sono, qui sola una nave ci addusse.
Io dei Mirmidoni sono, mio padre è Polittore: è ricco
di molti beni, ed ha sei figli, ed il settimo io sono.
Tratto fra questi a sorte, venuto qui sono alla guerra.
E dalle navi al piano mòvo ora: ché all’alba dimani
gli Achivi occhi rotondi daranno l’assalto alla rocca,
ché troppo a lungo inerti restare, li tedia; e tenere
più non li possono i re degli Achei: tanto braman la pugna».
E Priamo, il re che un Nume sembrava, cosí gli rispose:
«Se tu sei veramente scudiere d’Achille Pelide,
esponi tutto a me, senza nulla nascondermi, il vero:
presso le navi ancora si trova mio figlio, od Achille
l’ha fatto a brani già con la spada, l’ha dato ai suoi cani?».
E l’Argicida che l’anime guida, cosí gli rispose:
«No, divorato ancora non l’hanno né cani né uccelli,
ma giace ancora, o vecchio, vicino alla nave d’Achille,
tuttor presso alla tenda. Già sorte son dodici aurore,
e il corpo ancor marcito non è, né lo vorano i vermi
che pur rodono i corpi degli uomini spenti in battaglia.
Sempre, d’intorno al corpo del suo prediletto compagno,
appena è l’alba, senza pietà lo trascina il Pelide;
ma pur non lo deturpa: veder lo potrai da te stesso,
come rorida ancora la salma, e detersa dal sangue,
né punto lorda; e tutte si sono richiuse le piaghe,
quante ne aveva; ché molti su lui spinto avevano il ferro.
Tanto del figlio tuo si dàn cura i Beati Celesti,
sebbene egli sia morto: tanto essi l’amavan d’amore».
Cosí diceva; e, lieto, cosí gli rispose il vegliardo:
«O figlio, è saggia cosa le debite offerte ai Celesti
porgere. Il figlio mio, quando era ancor vivo, oblioso
non fu mai, nella reggia, dei Numi signori d’Olimpo,
perciò, pure nel fato di morte, han memoria di lui.
Orsù, dalle mie mani tu or questa coppa gradisci,
e me proteggi, e guida mi sii, con l’aiuto dei Numi,
sin ch’io presso la tenda d’Achille Pelide sia giunto».
E l’Argicida che l’anime guida, cosí gli rispose:
«Me che son giovine, o vecchio, tu tenti; né farmi convinto
potrai che accetti, senza che Achille lo sappia, il tuo dono.
Possibile non è, tanto io lo rispetto e Io temo,
ch’io Io defraudi; e poi, potrebbe colpirmi sciagura.
Ma per guidare te, verrei sino ad Argo l’eccelsa,
sopra una rapida nave movendo, movendo anche a piedi:
niun, s’io ti guido, potrà sprezzarti né offenderti, o vecchio».
E, cosí detto, il Nume benigno balzò sopra il carro,
rapidamente, in pugno stringendo la sferza e le briglie.
ed impeto gagliardo spirò nei cavalli e le mule.
Hermes infonde sonno alle guardie, e apre il recinto che conduce alla tenda di Achille; poi svela a Priamo la sua vera identità e si congeda.
Priamo entra nella tenda di Achille e lo supplica di ridargli il corpo di Ettore.
Achille ne ha pietà, riconoscendo che ha molto sofferto. Acconsente e fa preparare la salma.
Quando alle torri e al fosso poi giunsero, presso le navi,
dove da poco stavan le guardie, allestendo la cena,
sonno su tutti versò l’Argicida che l’anime guida,
e d’improvviso schiuse le porte, rimosse le sbarre,
e Priamo introdusse, col carro e coi fulgidi doni.
Cosí giunsero presso la tenda d’Achille Pelide.
Alta era questa. Al signore l’aveano i Mirmidoni estrutta,
tronchi tagliando d’abete: di sopra costrussero il tetto,
con le villose canne che avevan recise nei prati.
E attorno un gran recinto levaron pel loro signore,
tutto di fitti pali: chiudeva la porta una sbarra
sola d’abete: in tre la solevano spinger gli Achivi;
ed erano anche in tre quando aprire volevan la porta,
gli altri Mirmidoni: Achille bastava a sospingerla ei solo.
E allora Ermète, il Nume benevolo, al vecchio la schiuse,
e fece entrare i doni fulgenti pel divo Pelide,
e giù dal cocchio a terra balzò, tali detti gli volse:
«O vecchio, io sono a te venuto d’Olimpo: immortale
io sono, Ermète: a te per guida mandato m’ha Giove.
Ma ora io me ne vo di nuovo: al cospetto d’Achille
io non verrò: sarebbe davvero odioso, che un Nume
cosi palesemente largisse favori a un mortale.
Ma entra, e abbraccia tu le ginocchia al Pelide, e pel padre
pregalo, e per la madre divina dal fulgido crine,
e pel suo figlio, se mai potessi commovergli il cuore».
Poi ch’ebbe detto cosi, di nuovo si volse all’eccelsa
vetta d’Olimpo, Ermète. E Priamo balzò giù dal carro
al suolo, e Idèo lasciò. Rimase egli quivi, a tenere
muli e cavalli; e il vecchio andò difilato alla tenda
dov’era Achille, stirpe di Superi. E qui lo rinvenne,
ed i compagni eran tutti lontani da lui. Due soltanto,
Automedonte l’eroe, con Àlcimo prole di Marta,
s’affaccendavano. Aveva da poco lasciata la cena,
i cibi, le bevande: la mensa era ancora imbandita.
Senza esser visto, giunse qui Priamo; e, fattosi presso,
strinse, abbracciò le ginocchia d’Achille, le mani omicide,
terribili baciò, che trafitti gli avean tanti figli.
Come allorché sopra un uomo s’abbatte la grave sciagura,
che in patria un uomo uccise, che giunge fra genti straniere,
presso un possente signore: lo guardano tutti stupiti:
similemente Achille stupí, come Priamo vide.
Stupirono anche i due, guardandosi l’uno con l’altro.
E Priamo, ad Achille parlando, cosí favellava:
«Del padre tuo ricordati, Achille simile ai Numi,
annoso al par di me, su la soglia di trista vecchiezza;
ed i vicini, forse, che intorno gli stanno, anche lui
crucciano, e alcuno non v’è che allontani da lui la sciagura.
Ma pure, quegli, udendo parlare di te che sei vivo,
certo s’allegra nel cuore, sperando, ogni giorno che spunta
di rivedere il figlio diletto che torni da Troia,
lo non ho che sventure: ché tanti valenti figliuoli
ho generato in Troia, né alcuno più vivo mi resta.
Cinquanta, io, si, n’avea, quando giunsero i figli d’Acaia,
che dieci e nove a me nati eran dal grembo d’Ecùba,
avean gli altri le donne concetti nell’alto palagio.
Ai più di loro, Marte feroce fiaccò le ginocchia:
quello ch’era da solo presidio alla rocca e a noi tutti,
tu l’uccidesti or ora, mentre ei combattea per la patria,
Ettore: ed ora io vengo d’Acaia alle navi per lui,
per riscattarlo da te, recandoti doni infiniti.
Achille, abbi rispetto dei Numi, ricorda tuo padre,
abbi di me compassione: di lui molto più n’ho bisogno,
ché io patito ho quanto niun altri patì dei mortali,
io che alle labbra appressai la mano che il figlio m’uccise».
Cosí disse. E una brama gl’infuse di pianger pel padre.
La man gli prese, e il vecchio da sé dolcemente respinse.
E, nei ricordi immersi, l’uno Ettore prode piangeva
dirottamente, steso dinanzi ai piedi d’Achille:
ed il Pelide anch’egli piangeva, or pensando a suo padre,
ora a Pàtroclo; e tutta suonava di pianto la casa.
Ma poscia, quando Achille divino fu sazio di pianto,
e via dal seno, via dalle membra ne sparve la brama,
presto balzò dal seggio, levò di sua mano il vegliardo,
ch’ebbe pietà del capo canuto, del mento canuto,
e a lui si volse, queste veloci parole gli disse:
«O poveretto, molti dolori ha patito il tuo cuore.
Ma come, dunque, solo venire, alle navi d’Acaia
osasti ora, al cospetto dell’uomo che tanti tuoi figli
trafisse, e tanto prodi? Davvero, il tuo cuore è di ferro!
Ma via, su questo trono siedi ora, e, per quanto crucciato,
lasciamo che la doglia riposi per ora nel seno,
poiché nessun vantaggio deriva dal gelido pianto:
ché ai miseri mortali tal sorte largirono i Numi:
vivere sempre in pena: solo essi son privi d’affanni.
Perché sopra la soglia di Giove son posti due dogli
dei loro doni: due di tristi, ed un terzo è di buoni.
E quegli per cui Giove, del folgore sire, li mischi,
or nella mala sorte s’imbatte, ora poi nella lieta.
Ma quello a cui soltanto largisce i funesti, lo aggrava
d’ogni onta; e cruda fame lo incalza per tutta la terra,
e va randagio, e onore né uomo gli rende, né Nume.
Cosí dièro a Pelèo, da quando egli nacque, i Celesti
fulgidi doni: il primo fra gli uomini egli era: ricchezza
avea, felicità, dei Mirmidoni aveva l’impero,
e a, lui ch’era mortale, concessero sposa una Diva.
Ma il Nume, ai beni un male gli aggiunse: ché a lui nella casa
non nacquero figliuoli che fossero eredi del regno.
Un figlio solo, fuori di tempo, gli nacque, né quando
vecchio sarà, di lui potrà cura avere: ché lungi
a Troia io me ne sto, te vecchio, crucciando, e i tuoi figli.
Ed anche te sappiamo che un giorno eri, o vecchio, felice.
Fra quante genti nutre la sede di Màcare, Lesbo,
e sopra noi la Frigia, col pelago d’Elle infinito,
tu, dicono, eri, o vecchio, per figli e ricchezze beato.
Ora, poiché gli Uranii t’inflissero questa sciagura,
e guerre e stragi hai sempre di genti d’intorno alla rocca,
tollera; e il cuore tuo non affligger di pianto perenne.
Nulla guadagnerai, piangendo il tuo figlio diletto,
non lo resusciterai: chiamerai qualche nuovo malanno».
E a lui Priamo, il sire che un Nume pareva, rispose:
«No, non volere ch’io segga, progenie di Superi, mentre
Ettore giace insepolto vicino alla tenda; ma presto
scioglilo, ché questi occhi lo vedano; e i doni tu accetta,
ch’io t’ho recati, tanti. Goderli tu possa, e alla patria
tua ritornare, poiché compassione di me prima avesti,
si ch’io vivessi, e ancora godessi la luce del sole».
Ma bieco lo guardò, cosí gli rispose il Pelide:
«Vecchio, non fare, adesso, ch’io m’irriti. A scioglier tuo figlio
sono disposto: a me venuta è, mandata da Giove,
la madre mia diletta, la figlia del vecchio del mare.
Ed anche te, so bene, né, Priamo, tu mi deludi,
che qualche Nume t’ha guidato alle navi d’Acaia,
ché non avrebbe osato venire alcun uomo, per quanto
giovane fosse, al campo: sfuggir non poteva alle guardie,
né smover facilmente la sbarra potea della porta.
Non voler dunque, o vecchio, più oltre eccitare il mio cuore;
ché io disobbedire non debba al comando di Giove,
e te scacciar, sebbene tu supplice sei, dalla tenda».
Cosí diceva Achille. E il vecchio obbedí sbigottito.
Ed il Pelide balzò dalla tenda, che parve un leone:
solo non già: ché insieme moveano con lui gli scudieri,
Automedonte, l’eroe, con Àlcimo, ch’erano entrambi
cari su tutti, dopo la morte di Pàtroclo, al sire.
Essi di sotto al giogo disciolser le mule e i cavalli,
condusser nella tenda l’araldo del vecchio sovrano,
lo fecero sedere. Dal carro di solida ruota
tolsero poscia il riscatto ricchissimo d’Ettore. Solo
lasciaron due mantelli, lasciarono un càmice fino,
perché potesse il corpo coprire portandolo a casa.
Quindi, chiamate le ancelle, die’ ordine ch’unto e lavato
fosse; ma lungi: ché Priamo veder non dovesse suo figlio,
ché poi, crucciato in cuore frenar non potesse lo sdegno,
vedendo il figlio, e Achille dovesse a sua volta crucciarsi,
e morte dare al vecchio, frustrare di Giove i comandi.
Or, poi che l’ebber lavato, cosperso con olio le ancelle,
gli ebbero cinto alle membra un manto e una tunica bella,
allora Achille stesso lo prese e sul letto lo pose,
ed i compagni insieme con lui lo portaron sul carro.
E pianse Achille allora, chiamando il compagno diletto:
«Pàtroclo, non adirarti con me, se tu vieni a sapere
anche laggiù nell’Ade, che Ettore simile ai Numi
resi a suo padre; ché dato me n’ha non indegno riscatto.
Anche di questi doni la parte avrai tu che ti spetta».
Achille fa preparare la cena, e poi un letto per Priamo. E gli chiede quanti giorni dureranno i funerali di Ettore; Priamo dice che dureranno 11 giorni, e il 12esimo torneranno alla zuffa. Per tutto quel periodo Achille promette che non attaccherà i Troiani.
Così disse. E alla tenda di nuovo tornato, il divino Pelide,
sul trono istoriato sede’ donde prima era surto,
dal Iato opposto a Priamo, cosí favellando al vegliardo:
«Vecchio, tuo figlio è sciolto, cosí come tu pur bramavi,
sopra la bara giace. Diman, come sorga l’aurora,
quando lo porterai, lo vedrai. Si pensi ora alla mensa.
Niobe dal crine bello, anch’essa pensava a cibarsi,
a cui pur, nella casa morti eran ben dodici figli,
sei giovanette, e sei garzoni negli anni fiorenti.
Le uccise i figli Apollo, coi dardi dell’arco d’argento,
ch’era adirato con Niobe: Artèmide uccise le figlie
perché Niobe osò sé stessa uguagliare a Latona.
Disse che questa avea generati due figli, essa molti:
e quelli, solo in due, i suoi sterminarono tutti.
Giacquero nove giorni cadaveri; e alcuno non c era
per seppellir: ché in pietra le genti avea Giove converse:
li seppellirono infine nel decimo giorno gli Olimpi.
Ma, sazia infin di pianto, del cibo ebbe anch’essa ricordo.
Ora, conversa in rupe, fra gioghi deserti di monti,
nel Sipilo, ov’è fama che sia delle Ninfe la cuna,
che intorno all’Achelòo contesson, divine, le danze,
pur nella pietra, soffre la doglia voluta dai Numi.
Dunque, a nutrirci anche noi pensiamo, o divino vegliardo.
E piangere il tuo figlio diletto potrete più tardi,
quando in Troia l’avrai condotto; e sarà lungo pianto».
Disse. E sgozzò, balzato sui piedi, una pecora bianca.
La scorticarono poi, l’acconciarono bene i compagni,
fatta con arte a pezzi, l’infissero poi negli spiedi,
la fecero arrostire con cura, allestirono tutto.
Automedonte, dentro canestri eleganti, dispose
sopra la tavola il pane: divise le carni il Pelide.
Su le vivande imbandite gittarono tutti le mani:
e poi che fu placata la brama del bere e del cibo,
Priamo, di Dàrdano figlio, mirava, stupendone, Achille,
quale era, e quanto grande, che un Nume sembrava a vederlo.
E Achille anch’ei guardava, stupito, di Dàrdano il figlio,
il bello aspetto suo vedendo, ascoltandone i detti.
E poi che furon sazi cosí di guardarsi l’un l’altro,
Priamo a parlare prese per primo, che un Nume sembrava:
«Lascia che a letto io vada, progenie di Numi: ché presto
prendiam ristoro entrambi, sopiti nel sonno soave:
ché non si chiusero mai sotto í miei sopraccigli questi occhi,
da quando è per tua mano caduto il mio figlio diletto;
ma sempre gemo, sempre mi cruccio d’innumeri affanni,
nel mio cortile sempre mi voltolo fra la lordura.
Invece, adesso ho pane mangiato, purpureo vino
m’è per la gola sceso: finora non mero pasciuto».
Disse. E ai compagni e alle ancelle die’ ordine allora il Pelide
che sotto il portico un letto ponessero, e sopra, le coltri
belle, di porpora; e sopra stendessero ancora i tappeti
ed i villosi mantelli, ché il vecchio potesse coprirsi.
Quelle, stringendo in pugno le fiaccole, uscir dalla tenda,
e con sollecita cura fùr sùbito pronti due letti.
E disse allora Achille, di téma pungendogli il cuore:
«Dormi qui fuori, o caro vegliardo, ché alcun degli Achivi
giunger non debba qui, di quelli che son consiglieri.
che qui vengono a farmi proposte, ché n’hanno diritto.
Se nella buia notte qualcuno di lor ti vedesse,
lo ridirebbe al pastore di genti Agamènnone; e indugio
nascer potrebbe allora che tu riscattassi la salma.
Ma questo dimmi adesso, rispondimi senza menzogna,
per quanti giorni pensi che debba durare l’esequie
d’Ettore; e anch’io frenerò, tratterrò dalla pugna le genti».
E Priamo ad esso, il veglio che un Nume sembrava, rispose:
«Se d’Ettore divino tu vuoi ch’io provveda al sepolcro,
questo dovresti fare, se farmi tu vuoi cosa grata.
Tu sai che nella rocca siam chiusi, e lontana è la selva
da trasportare legna, ché invade terrore i Troiani.
Vorrei che nove dì nella casa durasse il compianto:
nel decimo vorrei seppellirlo, e alle genti un banchetto
funebre offrire: l’undecimo il tumulo alzar su la salma.
il dodicesimo poi, torneremo, se occorre, alla zuffa».
E Achille, eroe divino, dai piedi veloci, rispose:
«Ed anche questo, sia, vecchio Priamo, come tu brami:
sospenderò pel tempo che tu m’hai richiesto, la guerra.
E, cosí detto, schiuse la mano, e la destra del vecchio
strinse, perché non dovesse nel seno restargli timore.
E della casa cosí nel vestibolo presero sonno,
l’araldo, e Priamo, entrambi volgendo assennati pensieri.
E’ notte e tutti dormono. Ma Hermes sveglia Priamo e lo invita a fuggire via, perché è troppo pericoloso per lui passare la notte tra gli Achei. Lo aiuta ad allontanarsi inosservato.
Cassandra è la prima che vede avvicinarsi suo padre Priamo con il corpo di Ettore. Ecuba e Andromaca lo piangono.
E nel recesso Achille dormi della solida tenda,
e accanto a lui la figlia di Brise dall’omero bianco.
E tutti gli altri Dei, tutti gli uomini d’arme coperti,
dormian la lunga notte, domati dal dolce sopore.
Ma non aveva il Sonno ghermito il benevolo Ermète,
che con la mente andava cercando in che modo potesse
Priamo lungi dai legni recar, deludendo i custodi.
E a lui sul capo stette, cosí la parola gli volse:
«0 vecchio, al tuo periglio non pensi, che ancora tu dormi
fra genti a-te nemiche? Benigno fu adesso il Pelide:
hai riscattato adesso, con molti tuoi doni, tuo figlio;
ma per aver te vivo, riscatto tre volte maggiore
dare dovrebbero i tuoi figliuoli che vivono ancora,
se ti sapessero qui Agamènnone e tutti gli Achivi».
Cosí diceva. E il vecchio destò, sbigottito, l’araldo.
Al giogo strinse Ermète le mule e i cavalli, e pel campo
velocemente egli stesso li spinse; né alcuno li vide.
Ma quando al passo poi pervenner del rapido fiume,
del vorticoso Xanto, figliuolo di Giove, immortale,
Ermète si parti di qui verso i picchi d’Olimpo.
Sopra la terra tutta l’Aurora dal peplo di croco
già s’effondeva; ed essi spingean nella rocca i cavalli
con gemiti, con pianto: la salma portavano i muli.
Né alcun altro li vide, né uomo né donna elegante;
ma solamente Cassandra, che bella era come Afrodite.
Pergamo ascesa, vide da lungi il suo padre diletto
venir sul cocchio, e seco l’araldo di voce possente,
e vide Ettore sopra la bara, tirato dai muli.
E un ululo levò, mandò grido per tutta la rocca:
«Venite tutti voi, Troiani e Troiane, e vedete
Ettore! Un di’ vi piaceva vederlo tornar dalla pugna,
ch’era della città l’amore, e del popolo tutto!».
Cosí diceva. E niuno rimase, né uomo, né donna,
nella città; ché piombò su tutti dolore infinito;
e su la porta incontrarono il re che la salma recava.
Prima la sposa sua diletta e la nobile madre,
balzate sopra il carro, la salma diletta abbracciando,
si Iaceravan la chioma: la turba assisteva piangendo.
E qui l’intero giorno, sin quando giungesse il tramonto,
Ettore avrebbero pianto, gemendo dinanzi alle porte,
se non avesse il vecchio parlato dal carro alle turbe:
«Fatemi largo, ch’io passi coi muli: satolli di piànto
farvi potrete, quando condotto l’avrò nella reggia».
Cosí disse. E la turba s’apri, fece largo al suo carro.
Giunti alla reggia eccelsa, deposero quindi la salma
su traforato letto, chiamaron qui presso cantori
per intonare i lagni. Levaron con flebile voce
quelli la funebre nenia, seguiano coi lagni le donne.
Lamenti e cerimonia funebre
E Andromaca fra loro levò per la prima il lamento,
fra le sue mani il capo stringendo del prode suo sposo:
«Dai giovani anni, o sposo, tu parti, e me vedova lasci
entro la casa: il bimbo tu lasci, che ancóra non parla,
che generammo tu ed io, sventurati! Né credo ch’ei giunga
a giovinezza: ché prima sarà dalle cime distrutta
questa città, ché morto sei tu che a difenderla stavi,
la difendevi, guardavi le spose ed i teneri figli.
Esse dovranno ben presto partir su le concave navi,
ed io fra loro. E tu dovrai pur seguirmi, o mio figlio,
dove ti sarà forza piegarti a un indegno lavoro,
penare innanzi a un duro padrone; o qualcun degli Achivi
ti ghermirà, scaglierà, morte orribile, giù dalle torri,
crucciato perché forse tuo padre gli uccise un fratello,
oppure il padre, o un figlio: ché molti guerrieri d’Acaia
d’Ettore sotto ai colpi caduti, già morsero il suolo,
ché nella pugna funesta non era, no, dolce, tuo padre.
Perciò nella città lo piangono adesso le turbe.
Ettore, ai tuoi genitori tu lasci ineffabile pianto.
ma più che a tutti, a me rimangono affanni funesti:
ché tu non mi porgesti la man dal tuo letto di morte,
non mi dicesti una saggia parola di cui ricordarmi
potessi notte e giorno, versando l’amaro mio pianto!».
Cosí dicea piangendo, gemevano tutte le donne.
Ed Ecuba fra loro levava per prima il lamento:
«Ettore, al cuore mio diletto su tutti i miei figli,
sinché tu fosti vivo, tu fosti diletto ai Celesti:
essi si diedero cura di te, pur nel fato di morte.
Gli altri miei figli, Achille dai piedi veloci, vendeva,
come li avesse presi, di là dallo sterile mare,
condotti a Samo, ad Imbro, ai lidi nebbiosi di Lemno:
te, poi che t’ebbe tolta la vita col lucido bronzo,
ti trascinò lungamente di Pàtroclo intorno alla tomba,
che tu spengesti: e pure cosí non gli ese la vita.
Ed ora, tutto fresco mi stai nella casa, ed intatto,
simile in tutto ad uomo che Apollo dall’arco d’argento
abbia con le sue frecce benigne colpito ed ucciso».
Disse piangendo cosi, suscitando lamenti infiniti.
Elena terza poi, fra loro levava il lamento:
«Ettore, al cuore mio diletto fra tutti i cognati,
— ché Paride è mio sposo, che sembra all’aspetto un Celeste,
egli m’addusse a Troia: cosí fossi morta quel giorno! —
è questo l’anno già ventesimo ch’io sono a Troia,
da che di là partii, lasciando la terra materna,
né udito ho mai da te parola scortese o d’oltraggio;
anzi, se mai qualche altro rampogna mi fe’ nella reggia,
fratello tuo, sorella, cognata, o mio suocero stesso,
— ché mite ognor con me mio suocero fu come un padre —
tu con le tue parole solevi esortarlo e frenarlo,
con la mitezza tua, le tue concilianti parole.
Perciò col cruccio in cuore te lagrimo adesso, e me stessa.
Perché niun altri c’è nell’ampia città dei Troiani
mite e benigno con me, ché anzi mi aborrono tutti».
Cosí dicea piangendo, gemeva la turba infinita.
E il vecchio Priamo, queste parole al suo popolo volse:
«Troiani, alla città recate ora legna: ché Achille
quando mi congedò, promise che a darci molestia
non penserà, se prima non brillino dodici aurore».
Disse. Ed ai carri quelli giovenchi aggiogarono e muli,
e innanzi alla città s’adunarono sùbito tutti.
Per nove dì dalla selva recarono legna infinite;
ma quando apparve poi, fulgente, la decima aurora,
Ettore prode allora portaron piangendo, la salma
a sommo della pira deposero, accesero il fuoco.
Quando l’Aurora appari mattiniera, ch’a dita di rose,
d’Ettore intorno al rogo si venne accogliendo la gente.
E quando intorno poi qui furono tutti, e raccolti,
spensero prima tutta la pira col fulgido vino,
dovunque spinta s’era la forza del fuoco, poi l’ossa
bianche, versando pianto, raccolser fratelli e compagni,
e per le loro guance cadevano lagrime fitte.
Poi dentro un’urna d’oro racchiusero il cuore, e sovr’essa
morbidi, a ricoprirla, disteser purpurei pepli.
Dentro una cava fossa di poi la deposero; e sopra
immani e fitte pietre vi posero, e il tumulo in fretta
poi v’innalzarono. Intanto, vegliavano in giro le scolte,
se mai prima del tempo venisser gli Achivi all’assalto.
Poi, quando il tumulo fu levato, tornarono indietro,
e celebrarono tutti raccolti, un solenne banchetto,
di Priamo entro la reggia, del sire nutrito dai Numi.
D’Ettore questa fu, domator di corsieri, l’esequie.
{Iliade, libro XXIV – traduzione di Ettore Romagnoli}
mercoledì 15 febbraio 2023
Astenersi dal voto non basta.
Astenersi dal voto non basta.
In Italia, come in altre democrazie mature, partecipa alle tornate elettorali circa il 40 % degli aventi diritto, 6 su 10 potenziali elettori si astengono. Questa realtà dimostra come tanti individui ritengano inutile la farsa elettorale. Pensano che, comunque vada, nessun partito parlamentare possa migliorare la propria condizione di vita. Questa presa d’atto è positiva. Il capitalismo in ogni sua azione mira, essenzialmente, al profitto e alla rendita per la sua base di massa. La classe lavoratrice è solo uno strumento per giungere all’obiettivo. Profitto e rendita significano, per chi vive offrendo al mercato le proprie braccia o il proprio cervello, precarietà nel lavoro, condizioni di lavoro sempre peggiori, bassi salari, pensioni misere in età sempre più avanzata, disoccupazione, condizioni di vita sempre più insicure e basate più sulla sopravvivenza che non sul vivere la vita in tutto il suo splendore. Partiti parlamentari, dirigenti sindacali, mass-media, sondaggisti, percettori di profitto e rendita sono un circolo chiuso a difesa del capitale e delle sue regole. I lavoratori sono al di fuori del club, sottomessi al bisogno e alle necessità del capitale. A questa classe i pugilatori a pagamento con lingua da schiavi danno in pasto, oltre a una vita misera e malsicura, un insieme di false ideologie, illusioni, vane speranze e miti fasulli pur di allontanarli dalla coscienza della loro condizione e renderli disillusi, frustrati, individualisti e egoisti nella loro miserevole vita. La classe lavoratrice, pur avendo nel numero e nell’organizzazione finalizzati a una strategia, con momenti tattici, la sua arma vincente, si lascia intrappolare dal sistema e dai suoi ciarlatani. Il sindacato, che è lo strumento organizzativo per eccellenza, per difendere le condizioni di lavoro e di vita nell’immediato, purtroppo, per l’afasia dei lavoratori, lo si lascia in mano a individui borghesi o piccoli borghesi. Questa realtà ha visto negli ultimi decenni peggiorare il mercato del lavoro, le liquidazioni, le pensioni, i livelli salariali senza che vi fosse una risposta adeguata e incisiva. I burocrati sindacali arrivano sempre dopo e la risposta è inesistente di fronte agli attacchi portati dalla borghesia e piccola borghesia al proletariato. Se il nostro strumento fosse tolto dalle grinfie degli infiltrati e fosse nelle nostre mani, non staremmo a seguire le istanze borghesi e piccole borghesi, ma prepareremmo una nostra piattaforma basata su pochi punti , ma basilari per le condizioni di lavoro e di vita per chi lavora:
riduzione dell’orario di lavoro per aumentare l’occupazione;
sostanziosi aumenti salariali, i salari italiani sono tra i bassi del mondo;
riforma del mercato del lavoro, basato solo sul contratto a tempo indeterminato, full-time o part-time; tempo determinato solo per aumento del lavoro non prevedibile da concordare con il sindacato;
riforma degli uffici del lavoro nel senso che ogni nuovo lavoro deve passare da questi centri;
sugli ultimi due punti si è basata la riforma del lavoro in Spagna con risultati molto soddisfacenti per l’occupazione;
riduzione dell’età pensionabile, 60 anni per gli uomini e 57 per le donne, la cassa Inps per i lavoratori dipendenti è da sempre in attivo; la stessa Inps spende per le pensioni il 50 % della sua spesa, nonostante molte categorie siano da sempre in passivo, il resto è corrisposto per materie che dovrebbero essere in carico alla spesa dello Stato come l’assistenza;
salario minimo rappresentato dai contratti di lavoro;
rappresentanza sindacale basata sulla reale presenza numerica all’interno delle aziende per combattere i contratti pirati;
Salario di vita, affinchè nessuno si trovi a non avere la possibilità di affrontare momenti negativi del mercato.
Questa piattaforma andrebbe discussa con i lavoratori nelle assemblee e portata alle associazioni padronali e del governo, preparandosi alla lotta fin quando non vi siano risposte positive. La classe lavoratrice non si tirerebbe indietro con una tale piattaforma rivendicativa.
Invece, nonostante la drammaticità della situazione della nostra classe, il nostro sindacato, guidato da burocrati, attenti più agli interessi del Paese, ovvero del capitale e della rendita, nulla fanno se non pantomima parolaia.
D’altronde alla guida vi sono personaggi che hanno come riferimento i partiti parlamentari che rappresentano gli interessi del capitale e della rendita e che nella commedia ognuno recita la sua parte, ma mai in difesa di chi lavora.
Il nodo è se si sia per un sistema basato sui rapporti di produzione o per un sistema basato sui consumi. Il club di cui sopra è per il primo e in quella struttura non c’è posto per la libertà, l’uguaglianza, la giustizia sociale. Solo superando i rapporti di produzione e instaurando una dimensione socio-economica per il consumo, ogni essere umano potrà soddisfare le sue necessità materiali e spirituali e vivere la vita in tutto il suo splendore.
Ogni essere umano dalla nascita desidera una vita serena che soddisfi i suoi bisogni e cerca in ogni modo, a volte anche non lecito, di giungere a questa meta.
Ma le cose semplici in questa realtà diventano complicate da comprendere, il sistema spesso mette i paraocchi al nostro cervello, l’acqua spegne i fuochi, ma è un composto chimico formato da idrogeno e ossigeno.
Per conoscere e non lascarsi ingannare è necessario studiare, studiare, studiare. Solo acquisendo conoscenza e coscienza della realtà, possiamo aspirare a cambiarla e a spostare in avanti le lancette della storia.
“ Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’ignoranza.”
Socrate
domenica 5 febbraio 2023
Io sono comunista
Io sono comunista
• Io sono comunista
• Perché non vedo una economia migliore nel mondo che il comunismo.
• Io sono comunista
• Perché soffro nel vedere le persone soffrire.
• Io sono comunista
• Perché credo fermamente nell’utopia d’una società giusta.
• Io sono comunista
• Perché ognuno deve avere ciò di cui ha bisogno e dare ciò che può.
• Io sono comunista
• Perché credo fermamente che la felicità dell’uomo sia nella solidarietà.
• Io sono comunista
• Perché credo che tutte le persone abbiano diritto a una casa, alla salute, all’istruzione, ad un lavoro dignitoso, alla pensione.
• Io sono comunista
• Perché non credo in nessun dio.
• Io sono comunista
• Perché nessuno ha ancora trovato un’idea migliore.
• Io sono comunista
• Perché credo negli esseri umani.
• Io sono comunista
• Perché spero che un giorno tutta l’umanità sia comunista.
• Io sono comunista
• Perché molte delle persone migliori del mondo erano e sono comuniste.
• Io sono comunista
• Perché detesto l’ipocrisia e amo la verità.
• Io sono comunista
• Perché non c’è nessuna distinzione tra me e gli altri.
• Io sono comunista
• Perché sono contro il libero mercato.
• Io sono comunista
• Perché desidero lottare tutta la vita per il bene dell’umanità.
• Io sono comunista
• Perché il popolo unito non sarà mai vinto.
• Io sono comunista
• Perché si può sbagliare, ma non fino al punto di essere capitalista.
• Io sono comunista
• Perché amo la vita e lotto al suo fianco.
• Io sono comunista
• Perché troppe poche persone sono comuniste.
• Io sono comunista
• Perché c’è chi dice di essere comunista e non lo è.
• Io sono comunista
• Perché lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo esiste perché non c’è il comunismo.
• Io sono comunista
• Perché la mia mente e il mio cuore sono comunisti.
• Io sono comunista
• Perché mi critico tutti i giorni.
• Io sono comunista
• Perché la cooperazione tra i popoli è l’unica via di pace tra gli uomini.
• Io sono comunista
• Perché la responsabilità di tanta miseria nell’umanità è di tutti coloro che non sono comunisti.
• Io sono comunista
• Perché non voglio potere personale, voglio il potere del popolo.
• Io sono comunista
• Perché nessuno è mai riuscito a convincermi di non esserlo.
DARIO PULCINI
venerdì 3 febbraio 2023
La storia siamo noi!
Il capitalista nella produzione ha un ruolo sociale, non meramente personale. Il capitale è un prodotto comune e non può essere messo in movimento se non vi sia un’attività comune di parecchi membri, in ultima istanza da tutti i membri della società. Il capitale non è, quindi, una potenza personale, è una potenza sociale! Trasformando il capitale in proprietà comune, proprietari tutti i membri della società, si trasforma unicamente il carattere sociale della proprietà e si perde il carattere di classe. Il passato nel sistema capitalistico domina sul presente nel senso che continuano a esserci sfruttati e sfruttatori, nella società comunista il presente domina sul passato con l’eliminazione dei rapporti di classe e dando a ogni essere umano la possibilità di “ Dare secondo le sue capacità ed avere secondo le sue necessità”. “Nella società borghese il capitale è indipendente e personale, mentre l’individuo è dipendente e personale” Marx, Engels, Il manifesto del partito comunista. Si ribadisce il concetto che il capitale, pur appartenendo a persone o società, personale, è indipendente nel vivere nel mercato dove le volontà di ognuno sono condizionate dalle volontà di altri, mentre l’essere umano che è costretto a vendere o il proprio cervello o le proprie braccia è dipendente dal mercato e la sue facoltà, nel momento in cui vende la propria opera, appartengono al datore di lavoro. Di conseguenza è impersonale, ovvero esprime se stesso solo in qualità di prestatore d’opera. In una società borghese il singolo borghese si fa della sua libertà e della sua proprietà concetti “ Pro domo sua” universalizzando un concetto storicamente determinato e particolare. La libertà nel sistema attuale è intesa come libertà nel commerciare, nel fare affari, nel poter rincorrere il profitto, di poter meglio utilizzare la forza lavoro. Non è certo intesa nella soddisfazione dei bisogni materiali e spirituali della persona. Il comunismo vuole abolire tutto questo e dare all’essere umano una vita vera in una dimensione socio-economica che metta ogni persona nella condizione di avere soddisfazione di ogni necessità materiale e spirituale. In una società che ha come obiettivo la soddisfazione dei bisogni dell’umanità la produzione è per il consumo, non per la produzione e per il profitto. In questo contesto si realizza pienamente la persona. Nel capitalismo, invece, la persona è intesa solo come proprietario borghese . La cultura nel sistema borghese è propedeutica al sistema stesso, è un prodotto dei rapporti di produzione. Parimenti il diritto, che esprime la volontà della borghesia elevata a legge, il cui contenuto è dato dalle condizioni di vita di quella classe. In ogni epoca le idee dominanti sono quelle della classe dominante. Man mano che nella società si formano gli elementi di una nuova si affermano nuove idee che rappresentano nuovi rapporti economico-sociali, di vita. La materia è dinamica, non statica. Lo stesso concetto vale nella realtà socio-economica. Chi vede nel capitalismo l’ultima forma sociale ed economica fa torto alla scienza affermando la staticità della materia e ,quindi, della società. E’ un’opinione interessata , che viene portata avanti quasi in termini di legge eterna e naturale e nega la storia fatta di produzione e di proprietà storicamente determinata, di realtà sociali storicamente determinate. L’umanità ha bisogno di avere una vita vera, di godere dello splendore della vita! Non può accontentarsi delle briciole di vita che ci elemosina il sistema, a volte neanche quelle. Nel comunismo, causa di tutta l’umanità, vivrebbe meglio anche il capitalista nella sua essenza di essere umano, scevro da ogni pensiero “contro” e libero di esprimere l’idea “insieme”. Con lo sviluppo attuale della tecnologia, per la produzione di beni per l‘intera umanità basterebbe che ognuno desse 90 minuti al giorno, impegnato nei settori più consoni alle sue aspettative e capacità. Il resto della giornata ognuno potrebbe viverla come desidera e secondo le sue passioni. Quello che potremmo fare e avere in un sistema comune noi non riusciamo neanche a immaginarlo, succubi dei limiti che pone alla nostra mente il sistema attuale.
domenica 29 gennaio 2023
mercoledì 11 gennaio 2023
Conquistiamoci il futuro!
Conquistiamoci il futuro!
Nell’ultimo decennio la realtà della classe lavoratrice è peggiorata notevolmente. I salari hanno perso potere d’acquisto, i diritti sono stati ridimensionati, il mercato del lavoro è divenuto sempre più precario, la disoccupazione, mettendo insieme disoccupati, inattivi e scoraggiati, è aumentata a dismisura, l’età pensionabile è stata portata in avanti, le pensioni presenti e future sono state decurtate, le tasse continuano a pagarle solo i lavoratori dipendenti ed i pensionati. I vari governi succedutisi hanno legiferato sempre a difesa della borghesia e della piccola borghesia, spesso anche a favore degli evasori.
Chi vive di lavoro, vendendo sul mercato o il proprio cervello o le proprie braccia, vive male, sempre peggio..
Tutto ciò in un periodo, al di là delle enunciazioni, di profitti per le aziende, in alcuni casi da record.
Chi ha governato in questi anni, complici i partiti di opposizione, hanno schiacciato i lavoratori e i pensionati sempre più in basso.
Questo è potuto succedere sia per la fase d’inerzia del movimento dei lavoratori sia per mancanza di rappresentanza politica, che non si può identificare in alcun partito dell’arco parlamentare o di chi aspira a farne parte. I sindacati diretti dai partiti parlamentari si sono, ancora una volta, rivelati complici del baratro in cui versa la classe lavoratrice. Un sindacato diretto da lavoratori avrebbe lottato per aumentare i salari, l’Italia è l’unico Paese in cui gli stipendi sono diminuiti; per la riduzione dell’orario di lavoro a difesa dell’occupazione; per un’età pensionabile più bassa, 55 anni per le donne, 60 per gli uomini; per una sanità veramente pubblica e non sempre più privata; per una rete di trasporti adeguata alle esigenze dei cittadini; per una scuola palestra di apprendimento e non propedeutica solo allo sfruttamento produttivo, come succede per i tirocini.
Il gruppo di cui sopra si pone compatto a difesa del profitto e nulla può aspettarsi da questo strato la classe lavoratrice, se non parole, parole, parole.
Il nocciolo della questione è che o si è per il profitto o per il salario, non si può essere per ambedue.
O si è per il proletariato o per la borghesia!
Coloro che dicono, ma essi stessi non lo pensano possibile, di voler conciliare gl’interessi di tutte le classi sociali nel sistema capitalistico sono dei magliari della politica.
Il salario non è conciliabile con profitto e rendita.
Privilegiando il profitto, quindi il capitalismo, al di là della forma democratica o meno, si favorisce lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, le disuguaglianze sociali, le guerre in armi o diplomatiche, l’asservimento psichico e fisico di chi vive offrendo forza lavoro, la povertà e la miseria di larga parte del genere umano.
Per superare questa misera realtà per chi vive di lavoro la strada obbligata è lottare per una società senza classi, lottare per il comunismo, la sola che può garantire “a ognuno di dare secondo le sue capacità e avere secondo le sue necessità.”
Altre vie sono solo rappresentanze della fiera delle illusioni.
“Le illusioni somigliano ai fuochi d’artificio. Illuminano il cielo con una grande esplosione di colori, ma rapidamente si dissolvono e ritorna il buio.”
Anonimo
“Diverse lingue, orribili favelle,
parole di dolore, accenti d’ira,
voci alte e fioche, e suon di man con elle
facevano un tumulto, il qual s’aggira
sempre in quell’aura sanza tempo tinta,
come la rena quando turbo spira.
E io ch’avea d’orror la testa cinta,
dissi: “Maestro, che è quel ch’io odo?
E che gent’è che par nel duol sì vinta?”
Ed elli a me:” Questo misero modo
Tengon l’anima triste di coloro
che visser senza infamia e sanza lodo.
…Questi non hanno speranza di morte,
e la lor cieca vita è tanto bassa
che ‘nvidiosi son d’ogni altra sorte.
Fama di loro il mondo esser non lassa;
misericordia e giustizia li sdegna;
non ragioniam di loro, ma guarda e passa”.
Dante Alighieri, La divina commedia, Inferno.
Se vogliamo il futuro, dobbiamo conquistarlo! Mettendo in campo coraggio, coscienza, organizzazione.
Il numero è la forza dei lavoratori. Se organizzato e cosciente, nessuna frontiera è preclusa!
Iscriviti a:
Post (Atom)